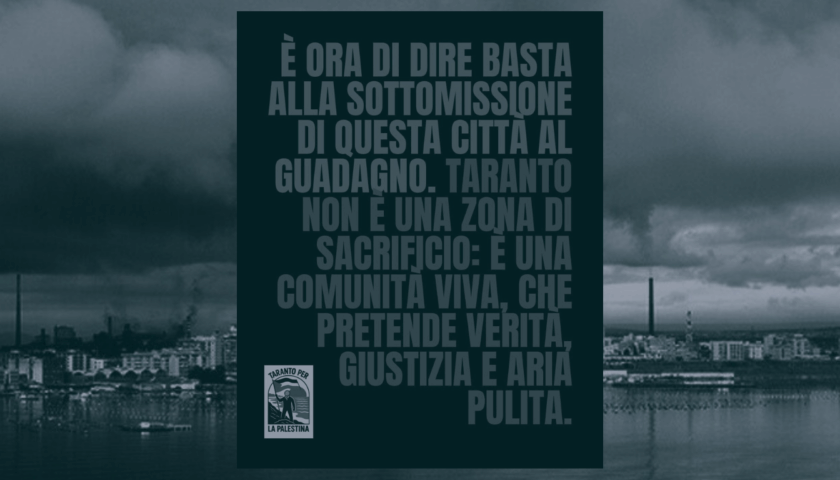Affrontare la realtà di Taranto non è semplice. Significa analizzare quello che può essere considerato un laboratorio di oppressione capitalista e militare, in cui sono presenti germogli di un conflitto che fatica a esplodere.
Per decifrare la bassa conflittualità che da anni caratterizza Taranto è necessario smontare il mito della sua “vocazione industriale” e cercare di capire la stratificazione che si è andata a determinare nel tempo e come si sono andate a costruire le catene di uno sviluppo imposto.
Partiamo dal controllo militare e industriale. Fino dal primo Novecento con l’Arsenale, poi con il colpo di mano degli anni ’60 (Italsider, Eni, Cementir), fortemente voluto da sindacati e partiti di governo e di opposizione, lo stato ha forgiato un distretto funzionale alla sua strategia militare e produttiva. Questo asse si è consolidato con la presenza della Marina Militare e di una base NATO cruciale, che insieme a Brindisi forma un cardine della proiezione atlantica nel Mediterraneo. Proprio la base NATO e le aziende del comparto militare (es. Leonardo) rendono attualmente Taranto un hub strategico per le guerre nel Mediterraneo.
La costruzione di questa identità militare e industriale si è accompagnata ad un sabotaggio sistematico dell’istruzione. La mancata costituzione di un polo universitario negli anni ’70 e ’80 non fu una casualità, ma una precisa scelta politica. Si voleva evitare la pericolosa miscela di lotte studentesche e operaie, mantenendo la conflittualità a un livello basso e facilitando il controllo sociale.
Nel tempo la città è stata anche un laboratorio neoliberista: Taranto è stata un banco di prova per politiche populiste (il sindaco fascista Cito) e neoliberali. Con la giunta Di Bello si sperimentarono i Buoni Ordinari Comunali (BOC), strumenti finanziari speculativi che portarono la città al fallimento, con i costi scaricati sui servizi e sul proletariato. Contemporaneamente, si è avuta la strutturazione di una classe parassitaria, una piccola borghesia locale, resa parassitaria dai fasti di un’aristocrazia operaia ormai estinta e incapace di immaginare un futuro diverso. Il risultato è un territorio con disoccupazione alle stelle, migrazione forzata e un proletariato massicciamente precarizzato. In questo quadro, le lotte che emergono sono frammenti di un’unica resistenza contro un sistema ecocida in cui l’ex Ilva ha un ruolo centrale.
I numeri della depredazione parlano chiaro. L’ex Ilva produce meno del 10% dell’acciaio italiano, è costantemente in perdita e ha bisogno di continui “salvataggi” statali. Inoltre preleva 12,5 milioni di m³/anno dal Fiume Tara, una risorsa che basterebbe per il consumo potabile di tutta Taranto e una immensa quantità di acqua prelevata dal Mar Piccolo.
La vertenza ex Ilva: tra territorio considerato zona di sacrificio e farsa dell’acciaio verde.
La pluridecennale agonia dell’ex Ilva è la rappresentazione più chiara dell’immobilismo e della malafede del potere. I passaggi di proprietà (da Italsider a Riva, poi ad ArcelorMittal) non hanno fatto che prolungare le sofferenze di un impianto obsoleto e non competitivo. A ciò si è aggiunta la fuffa della transizione: il ministro Urso parla di “acciaio verde”, forni elettrici (DRI) e decarbonizzazione. Nella realtà, con l’ultimo Accordo di Programma si è rinviato di 12 anni l’abbandono del carbone, chiedendo un’AIA (autorizzazione integrata ambientale) per produrre 6 milioni di tonnellate con le tecnologie inquinanti di sempre, che confermano Taranto come zona di sacrificio, come dichiarato anche dal relatore Onu Marcos Orellana. I sindacati confederali e di base non vanno oltre lo slogan sterile della “nazionalizzazione”. Non esiste un piano credibile, né una reale conflittualità operaia in grado di autodeterminarsi al di fuori di queste logiche.
L’ostinazione a tenere in vita questo “cadavere che cammina” si spiega solo con la mancanza di una visione strategica di riconversione (come avvenuto a Bilbao) e con la necessità, in uno scenario di economia di guerra, di mantenere quote di produzione nazionale di acciaio, a qualunque costo, umano e ambientale. Né vanno trascurati altri aspetti, come ad esempio il fatto che le varie industrie del territorio, in primis l’ex Ilva, hanno, tra le altre cose, anche un grande impatto nell’alterazione del fragile e importantissimo ecosistema del Mar Piccolo; su questo incide pure la pesca di frodo finalizzata anche al commercio illegale. Il segnale di una connessione perversa tra impoverimento, criminalità e depredazione del vivente.
Di fronte a tutto questo, un coordinamento di cittadini e associazioni, a proprie spese, sta promuovendo il ricorso contro la nuova AIA, dopo che il Comune si è rifiutato di farlo. È un segnale di resistenza, ma la strada per un conflitto radicale e determinato è ancora lunga.
La vertenza sul Dissalatore: l’acqua merce del capitale
La mobilitazione contro il dissalatore sul fiume Tara non nasce con il coordinamento “No Dissalatore”, ma affonda le sue radici in un percorso di impegno territoriale ben più ampio e di lunga durata. Da quasi tre anni, comitati, associazioni e cittadini attivi hanno dato vita a un’opposizione informata e fondata, mettendo in discussione, nel merito, l’opera e la sua presunta necessità. La battaglia contro il dissalatore sul fiume Tara smaschera l’ipocrisia della cosiddetta “transizione ecologica”. Spacciato come opera per l’acquedotto pubblico, è in realtà un’infrastruttura al servizio del complesso industriale, in primis l’ex Ilva.
Il coordinamento No Dissalatore contesta questi punti: 1) inefficienza pilotata: in Puglia si perde oltre il 50% dell’acqua immessa in rete. Il problema non è la carenza, ma il saccheggio e la mala gestione; 2) soluzione inquinante e costosa: si tratta di un’opera da 130 milioni di euro che produrrà acqua a un costo triplo rispetto al riuso delle acque reflue, con un’enorme impronta di CO₂; 3) danno ambientale: l’opera altererà l’ecosistema di uno dei fiumi naturali del territorio; 4) modello sbagliato: si preferisce un modello lineare (preleva, trasforma, scarica) a un modello relazionale e rigenerativo, basato sulla riduzione degli sprechi, sul riuso e su una gestione comunitaria della risorsa.
Siamo davanti a un’opera che ha un costo di 130 milioni di euro (27 dal PNRR), con tecnologia a osmosi inversa, quando l’AIA del 2011 imponeva già all’ex-Ilva di usare le acque reflue depurate della città (impianti di Gennarini e Bellavista). Un progetto mai realizzato, perché è più comodo far pagare alla collettività nuove opere.
La nuova discarica di Paolo VI: l’ecocidio quotidiano
Il territorio di Taranto è già un hotspot europeo per le discariche (Grottaglie, Lizzano, Statte). Ora, con un escamotage burocratico, si vuole imporre un nuovo impianto per inerti (una discarica) a 800 metri dalle case del quartiere Paolo VI, già tra i più colpiti dall’inquinamento dell’ex Ilva.
Nonostante i pareri negativi ripetuti di ARPA e enti di controllo, la Provincia fa leva sul silenzio-assenso di un Comune inerte i cui consiglieri, a tre anni dalla proposta, ammettono di “non aver ancora letto le carte”. Il comitato No Discarica Paolo VI conduce una duplice lotta: di opposizione diretta all’opera e di sensibilizzazione per una gestione razionale e comunitaria dei rifiuti, contro gli interessi di imprenditori senza scrupoli e ecomafie.
Taranto per la Palestina: il filo rosso della complicità
La solidarietà internazionalista a Taranto non è un tema astratto, ma la presa di coscienza di un nesso materiale tra lo sfruttamento del territorio e le guerre globali. Il coordinamento Taranto per la Palestina, nato da realtà libertarie, di antagonismo e autorganizzazione, di sindacalismo di base e studentesche, ha organizzato presidi, manifestazioni e iniziative culturali. Alcuni attivisti palestinesi hanno saputo tessere un filo rosso tra l’apartheid di Gaza e il “genocidio a bassa intensità” di Taranto, capitale italiana dei tumori ed hanno rinominato la loro piece artistico-militante, in “Parlami di Gaza e di Taranto”.
Le connessioni del resto sono evidenti. Taranto è un hub strategico per la guerra. La Leonardo a Grottaglie produce droni e l’Eni rifornisce di greggio l’aviazione israeliana. La stessa Eni che ha forti interessi nell’estrazione e sfruttamento del gas davanti alla costa di Gaza.
Lo scorso 24 settembre il coordinamento Taranto per la Palestina e sindacati di base (Cobas, USB) hanno tentato di bloccare il rifornimento della petroliera Seasalvia, carica di 30.000 tonnellate di greggio per Israele. Inizialmente Eni e Autorità portuale avevano dichiarato che la nave non si sarebbe rifornita, cosa poi avvenuta nei giorni successivi. Il 27 Settembre subito dopo la manifestazione regionale pugliese contro la Leonardo di Grottaglie, circa 200 attivisti hanno cercato di bloccare al varco dell’Eni i rifornimenti della Seasalvia. Senza l’appoggio dei portuali, l’azione è rimasta simbolica, ma ha alzato il livello dello scontro.
La legge 185 del 1990 vieta l’esportazione di armamenti verso paesi in guerra o che commettono violazioni dei diritti umani. Il governo e le autorità portuali la calpestano sistematicamente, rendendosi complici del genocidio. Davanti al muro di gomma di Comune e Prefettura, che negano le loro stesse responsabilità e violano la legge 185, il coordinamento ha intensificato la controinformazione e i presidi, preparando una manifestazione regionale contro l’Eni ancora in data da definirsi. Intanto sono proseguite e proseguono le iniziative, tra cui: l’accoglienza e il supporto dell’imbarcazione della Freedom Flotilla “Gasshan Kanafani” al molo Sant’Eligio di Taranto; il monitoraggio della nave Seasalvia pronta a caricare altre 30 mila tonnellate di greggio destinate ad Israele; le assemblee pubbliche del comitato No Discarica Paolo VI e del coordinamento No Dissalatore; le iniziative di solidarietà con la Palestina e contro la complicità delle aziende del territorio. Di particolare importanza la manifestazione “L’ora di Taranto”, prevista il 23 novembre con tutte le realtà associative e movimenti di lotta. per dire no al salvataggio dell’ex Ilva e chiedere la riconversione economica del territorio.
Verso una lotta sistemica
Le vertenze di Taranto non sono isole separate. Sono tasselli di un unico attacco capitalista che ha come matrice: lo sfruttamento ecocida per il profitto (ex-Ilva, dissalatore, discariche); il controllo militare del territorio (basi NATO, Leonardo); la complicità nella guerra imperialista (Eni, rifornimenti a Israele); il sabotaggio della capacità di ribellione (assenza dell’università, precarietà, sindacati e forze politiche istituzionali complici).
La sfida per i movimenti antagonisti è proprio questa: collegare i fili e mostrare le connessioni tra le varie questioni. Solo un conflitto che unisca le rivendicazioni ambientali a quelle sociali e internazionaliste, praticando l’autorganizzazione e l’azione diretta, potrà rompere l’assedio e aprire uno spazio di liberazione, che possa in un prossimo futuro concretizzarsi in uno sciopero sociale con blocco della città.
Walterego
Cosimo Cassetta