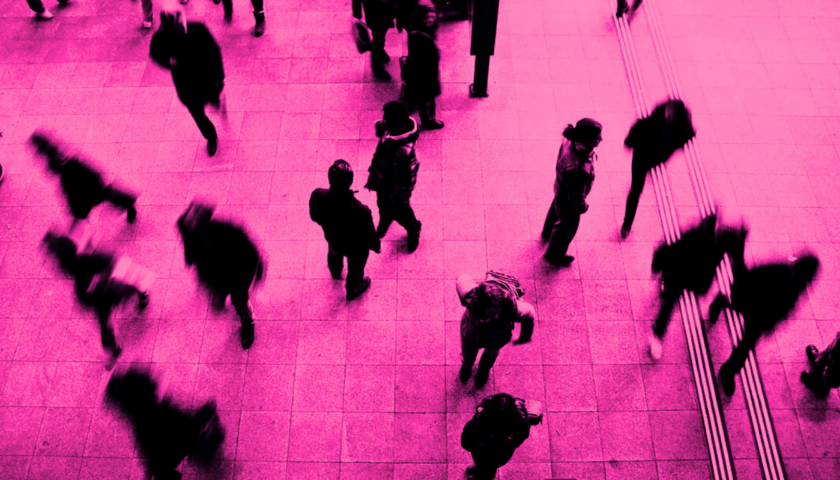Ogni anno, in questo periodo la società dello spettacolo ci propina il cine-panettone, la società dei consumi addobba l’albero dei doni, la cristianità moltiplica presepi viventi. E, puntuale come un rito laico, arriva anche il Rapporto Censis: la grande fotografia dell’Italia.
Una fotografia che sembra neutrale, ma che riflette soprattutto lo sguardo di chi la scatta. Il popolo diventa fauna da osservare; il conflitto si trasforma in “malessere”; la povertà in “febbre del ceto medio”. Eppure i numeri dicono altro: un Paese impoverito, sfruttato, precarizzato, che vive alla giornata perché gli hanno sottratto il futuro.
La narrazione che sostituisce l’analisi
La prosa del Censis – “età selvaggia”, “barbari”, “Grand Hotel Abisso” – non serve a capire, ma a neutralizzare. Processi economici diventano stati d’animo; scelte politiche diventano fatalità psicologiche. Deindustrializzazione? “Autunno dell’industria.” Precarietà? “Instabilità.” Salari stagnanti? “Affanno.” Povertà crescente? Non pervenuta. Un lessico che depoliticizza tutto: niente capitale, niente sfruttamento, niente responsabilità politiche. Solo percezioni. Perché il Censis parla del ceto medio e non della povertà? La categoria centrale del Rapporto è sempre la stessa: il ceto medio. Non per caso. Il ceto medio è la platea a cui parlano le élite: la zona cuscinetto che garantisce stabilità sociale. La povertà, invece, obbligherebbe a parlare di salari fermi da decenni, precarietà strutturale, welfare smantellato, evasione impunita, ricchezza privata concentrata. Meglio trasformare la questione sociale in ansia collettiva. Meglio parlare di “declino percepito” che di disuguaglianza prodotta.
Il “Grande Debito”: austerità mascherata da necessità
Il Censis presenta la crescita del debito pubblico come un destino naturale che impone il ridimensionamento del welfare. Il messaggio implicito è chiaro: lo Stato non può più permettersi di garantire diritti sociali. Ma si tace su chi ha beneficiato per anni di politiche fiscali indulgenti, chi alimenta l’evasione, chi ha guadagnato dalla privatizzazione dei servizi. Gli interessi sul debito pesano più della spesa per ospedali e scuole: vero. Ma il Rapporto non si chiede perché devono pagarli le persone comuni e non i grandi patrimoni. Il “Grande Debito” diventa così il linguaggio elegante con cui si giustifica l’austerità permanente.
Il militarismo come risposta distorta alla crisi
Il rapporto del Censis ammette un dato decisivo: mentre la manifattura arretra, l’industria delle armi cresce del 32%. È l’unico settore in aumento.
La nuova politica industriale del Paese, dunque, non parla più di innovazione, scuola, ricerca, lavoro qualificato. Parla di riarmo. L’Italia segue la corsa al 2% del PIL in spesa militare, mentre i fondi per sanità, trasporti e case popolari vengono considerati “insostenibili”. Non è un dettaglio: è la trasformazione dello Stato sociale in Stato armato.
Il militarismo non risponde alla crisi: la consolida, spostando risorse dai diritti alle armi e dai bisogni popolari alle logiche geopolitiche.
Conclusione
Ogni dicembre il Censis ci consegna la sua immagine dell’Italia. Una fotografia che invita all’adattamento, non al cambiamento; alla rassegnazione, non alla lotta. Ma dietro la retorica del “ceto medio in ansia” c’è un Paese impoverito. Dietro l’“età selvaggia” c’è un modello economico che non funziona. Dietro il “Grande Debito” c’è l’austerità. Dietro la “corsa al riarmo” c’è il sacrificio del welfare. Il nostro compito è rompere questa cornice, restituire parole al conflitto, dare un nome ai responsabili e forza alle lotte di chi questa crisi la vive sulla propria pelle. Perché non è l’Italia ad essere selvaggia: è il capitalismo che la governa. E nessun rapporto annuale potrà raccontare ciò che racconta la resistenza quotidiana collettiva.
Totò Caggese