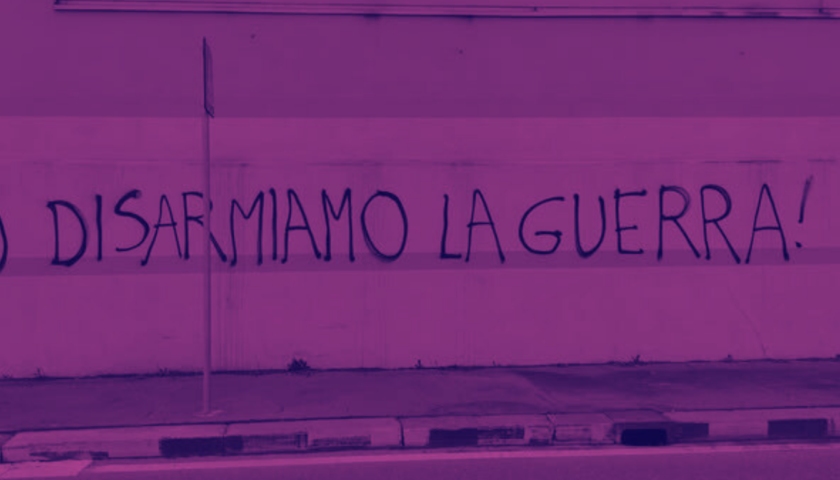Scritto da sei insegnanti della secondaria superiore, un dirigente scolastico in pensione ed un docente universitario circa un mese fa, un appello[1] volto a chiedere una “moratoria” alle disgraziate conseguenze delle riforme scolastiche degli ultimi vent’anni circa ha avuto un successo straordinario, raggiungendo nel momento in cui scriviamo queste righe quasi diecimila sottoscrizioni[2] da parte dei lavoratori del mondo dell’istruzione e della ricerca, divenendo grazie anche all’adesione di molti “nomi noti” un piccolo caso mediatico e giungendo il 30 dicembre, come suol dirsi, agli onori della cronaca di uno dei maggiori quotidiani nazionali,[3] il che ne ha fatto rimbalzare la notorietà ed aumentare le adesioni.
Scritto da sei insegnanti della secondaria superiore, un dirigente scolastico in pensione ed un docente universitario circa un mese fa, un appello[1] volto a chiedere una “moratoria” alle disgraziate conseguenze delle riforme scolastiche degli ultimi vent’anni circa ha avuto un successo straordinario, raggiungendo nel momento in cui scriviamo queste righe quasi diecimila sottoscrizioni[2] da parte dei lavoratori del mondo dell’istruzione e della ricerca, divenendo grazie anche all’adesione di molti “nomi noti” un piccolo caso mediatico e giungendo il 30 dicembre, come suol dirsi, agli onori della cronaca di uno dei maggiori quotidiani nazionali,[3] il che ne ha fatto rimbalzare la notorietà ed aumentare le adesioni.
Il documento parte dalla premessa per cui “l’ultima riforma della scuola è l’apice di un processo pluridecennale che rischia di svuotare sempre più di senso la pratica educativa e che mette in pericolo i fondamenti stessi della scuola pubblica”, per poi individuare – a mio avviso lucidamente – i punti nodali di questo “processo pluridecennale” in sette aspetti: “1. Conoscenze vs competenze 2. Innovazione didattica e tecnologie digitali 3. Lezione vs attività laboratoriale 4. Scuola e lavoro 5. Metrica dell’educazione e della ricerca 6. Valutazione del singolo, valutazione di sistema 7. Inclusione e dispersione”.
Viene, perciò, innanzitutto evidenziata la retorica ideologica delle “competenze”, perché “una scuola di qualità è basata sulla centralità della conoscenza e del sapere costruiti a partire dalle discipline. (…) Crediamo che (…) Aggregare compiti e prestazioni degli allievi attorno a competenze predefinite e standardizzate annienti l’organicità dell’educazione, riduca la complessità del mondo ad un “kit di pratiche”, che tali restano, anche con l’appellativo onorifico di “competenze di cittadinanza”. Aggiungeremmo noi che questa retorica delle competenze, fattasi prassi didattica obbligata, non fa altro che svilire l’acquisizione di queste stesse competenze, in quanto la vituperata o quanto meno sminuita conoscenza dei saperi “tradizionali” è al fondamento di ogni competenza. Via le conoscenze, via le competenze, insomma – e chiunque operi nel mondo dell’istruzione sa bene come entrambe sono in caduta libera, di riforma in riforma.
Sulla questione dell’innovazione didattica e delle nuove tecnologie, il testo ricorda come “innovare non è bene di per sé (…) La didattica “innovativa” o digitale, oggi presentata come primaria necessità della Scuola, non vanta alcuna legittimazione scientifica né acquisizione definitiva da parte della ricerca educativa. Innovazioni e tecnologie, nelle varie accezioni global-ministeriali (debate, CLIL, flipped classroom, etc), rappresentano un insieme di “riforme striscianti” che demoliscono pezzo a pezzo l’edificio della Scuola Pubblica dal suo interno” e che “l’inflazione di innovazioni didattiche e gli sperimentalismi digitali offrano spesso narrazioni impazienti ed elementari (slides, video, “prodotti”, progetti), propongano procedure stereotipate e associazioni banali, con grave danno per gli studenti e la loro crescita culturale, interiore e sociale.” A ciò si collega il discorso sulla centralità della lezione, perché “attenzione concentrata, aumento dei tempi di ascolto, [sono] condizioni per un ‘saper fare’ come ‘agire intelligente’, che non si consegue assecondando l’uso delle tecnologie o seducendo gli alunni con dispositivi smart, ma in contesti di applicazione laboriosa, tempo quieto per pensare, discussione nel gruppo.”
D’altronde, aggiungeremmo, i livelli nettamente superiori degli studenti dei decenni passati sono stati ottenuti all’interno di un processo educativo basato quasi esclusivamente sulla lezione frontale, lavagna e gesso, con al massimo un proiettore per le antenate delle slides digitali. Questo non significa ovviamente che, per esempio, una lavagna digitale od un laboratorio siano inutili, anzi, ma che essi devono servire alla lezione frontale, l’unica forma educativa che, allo stato delle cose, abbia mostrato la sua efficacia e non, invece, ostacolarla. Il che, invece, sembra proprio la direzione suggerita dalle indicazioni governative.
Condivisibilissima poi la critica alla questione della famigerata Alternanza Scuola-Lavoro. “Dal liceo del centro storico al professionale di estrema periferia, la scuola era e deve restare, per primo, un ‘luogo potenziale’ in cui immaginare destini e traiettorie individuali, rimettere in discussione certezze, diventare qualcos’altro dalla somma di ‘tagliandi di competenza’ accumulati e certificati. L’apertura alla realtà sociale e produttiva può realizzarsi, volontariamente, attraverso forme e progetti di scambio organizzati autonomamente dagli istituti scolastici. Non imposti ex lege dal combinato Jobs Act e Buona Scuola. Pratiche calibrate in base ai contesti e alle finalità educative, che in nessun modo gravino sulle famiglie o sugli allievi in termini di sostenibilità e gestione. Crediamo che: i) L’alternanza scuola lavoro non rappresenti affatto un’opportunità formativa per i ragazzi, quanto piuttosto una surrettizia sperimentazione del “lavoro reale” che entra fin dentro i curricula scolastici, sottraendone tempo e qualità e distorcendone le finalità. ii) Oltre ad approfondire il solco tra sapere teorico e pratico, alternanza è sinonimo di disuguaglianza. Percorsi ineguali in base a contesti, tessuti sociali e reti familiari, che peggiorano in proporzione alla fragilità delle condizioni economiche e delle opportunità culturali di luoghi e famiglie. iii) Bisogna recuperare l’idea di Scuola come luogo della vita dotato di un tempo e spazio propri, non corridoio di passaggio tra infanzia e adolescenza – considerate età ‘minori’ – e occupazione adulta. iv) Sia necessario portare la conoscenza del lavoro nelle classi, non gli studenti a lavorare. Logiche, dinamiche e problematiche dell’occupazione entrino nel dialogo educativo, per aiutare i giovani ad orientarsi, attrezzarsi a comprenderle e intervenire per modificarle.”
L’ultimo punto merita un commento. La legge 107 – vigliaccamente detta la “Buona Scuola” dal governo Renzi – è stata preceduta, alcuni anni prima, dalla riforma cosiddetta “Gelmini”. L’aspetto più particolare della riforma in questione fu la riduzione secca delle ore di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore non liceale – taglio che venne effettuato sulle ore cosiddette di “laboratorio”. In altri termini, quelle ore in cui negli istituti tecnici e professionali si simulava l’esperienza lavorativa all’interno di un luogo protetto qual era la scuola, in modo da non lavorare gratis sotto padrone e togliere lavoro a se stessi ed agli altri e, allo stesso tempo, acquisire determinate professionalità. Ovviamente si trattava di ore importanti per la formazione di tali indirizzi e la 107 ha avuto buon gioco a dire che una tale formazione serviva: peccato che, invece di reintrodurre le ore di laboratorio perdute, ha proprio mandato centinaia di migliaia di giovani a lavorare gratis sotto padrone, togliendoli opportunità di lavoro retribuito.
Il testo continua poi con una critica della metrica dell’educazione e della ricerca basata su di un criterio competitivo regolato da agenzie di rating nazionali ed internazionali e basato su presupposti molto discutibili, che porta ad un appiattimento degli scopi formativi, generando “condotte di mero opportunismo metodologico-didattico e scientifico nonché la perdita di ‘biodiversità culturale’, strumento indispensabile per affrontare le complessità del futuro, oggi imprevedibili,” per poi passare alla questione della valutazione: “Valutare e Punire” era l’indicativo titolo di un testo di pochi anni fa, le cui tesi vengono sostanzialmente riprese dall’appello,[4] la cui analisi termina con desolata constatazione che i processi di inclusione la lotta alla dispersione costano, e tanto, ma il governo da un lato toglie al mondo dell’educazione ogni anno di più i fondi che servirebbero allo scopo, dall’altro la colpevolizza perché non riesce a raggiungerlo.
Gli elementi analitici dell’appello convergono verso un dato che oramai è evidente: il potere politico ed economico vuole rendere la scuola sempre più incapace di svolgere il proprio compito. Un dato, però, che a questo punto, va spiegato.
Dalla creazione delle prime gerarchie politiche e sociali circa cinquemila anni fa a pochi secoli se non solo decenni fa, l’istruzione è stata appannaggio – in maniera diretta o indiretta[5] – quasi esclusivamente delle classi superiori. La formazione della società industriale ha, però, portato la necessità dell’istruzione almeno parziale delle classi inferiori per poter operare adeguatamente nel nuovo contesto, ben più complesso della produzione agricola e/o artigianale, e questo ha portato gradatamente ad una inclusione almeno parziale delle classi lavoratrici all’interno dei processi educativi, un processo che è esploso nei “trent’anni gloriosi”, quando i figli delle classi inferiori hanno avuto accesso ad una istruzione secondaria ed universitaria di qualità – in quanto pensata per i figli delle classi dominanti. Il sapere, però, è potere, è capacità di discernere la realtà delle cose, gli inganni e le fallacie dell’ideologia dominante ed ha portato a generazioni di classi inferiori ribelli e poco docili.
Le riforme della scuola che si sono viste in questi decenni in tutto il mondo – l’Italia è solo un caso particolare, con minime tipicità – sono il risultato, pertanto, di una doppia prospettiva. Da un lato, la diminuzione della qualità dell’educazione implica una spesa minore da dedicare alle classi inferiori: a che scopo gettare le perle ai porci, se, statisticamente, anche da un’educazione di merda comunque una qual certa percentuale di individui che hanno acquisito un’educazione sufficiente agli scopi del capitale ci sarà sempre? Dall’altro, l’ideale del potere è racchiuso proprio nell’idea di un sottoposto con competenze ma privo di conoscenze – che questo sia possibile è un altro paio di maniche, ma i sogni ideologici hanno una forte potenza performativa nei confronti dei comportamenti del potere.
Enrico Voccia
NOTE
[1] “Appello per la Scuola Pubblica. Un documento sulla Scuola e sull’Istruzione. Da leggere, pensare e sottoscrivere”. https://sites.google.com/site/appelloperlascuolapubblica/
[2] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWJtm5ue9h0Ug-wV2kHX63i4o4gR8-xBZ_ILM9zIkcM/edit#gid=2040011136
[3] http://www.repubblica.it/scuola/2017/12/30/news/_una_moratoria_sulla_buona_sucola_l_appello_degli_insegnanti_firmato_da_intellettuali_e_accademici-185485819/
[4] PINTO, Valeria, Valutare e Punire. Una Critica della Cultura della Valutazione, Napoli, Cronopio, 2012.
[5] In alcune società antiche, tra le classi elevate c’era l’abitudine di affidarsi per la lettura e la scrittura a degli schiavi che svolgevano questo compito al loro posto. Per quanto sia paradossale, non è escluso che anche alcuni grandi pensatori del passato fossero, tecnicamente, degli analfabeti. Aristotele era detto “il lettore” quando frequentava giovanetto la scuola platonica perché leggeva da solo, senza l’ausilio di uno schiavo – il che implica che la maggioranza degli altri, forse lo stesso Platone, se ne servisse.