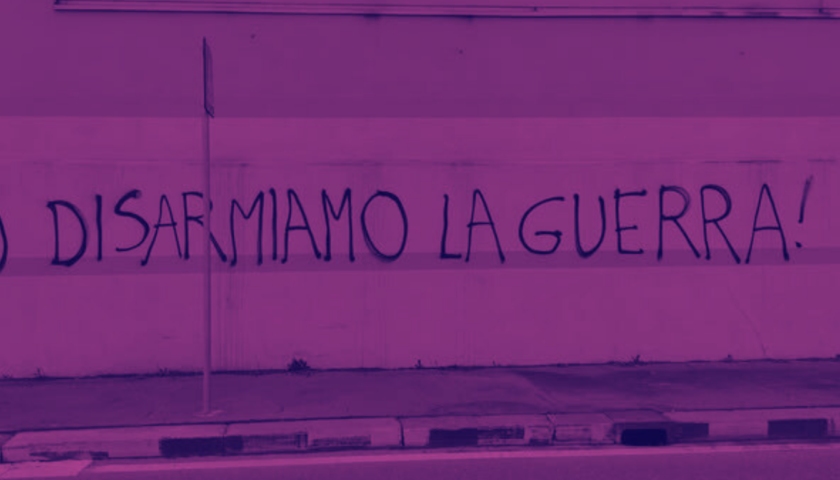L’evoluzione tecnologica della seconda metà del Novecento ha indubbiamente modificato in modo profondo non solo la prassi – vale a dire il prospetto operativo nelle diverse attività produttive e nella percezione delle aspettative di confort e di performatività – ma altresì il modo di interpretare la dimensione umana e le coordinate di antropo-poiesi. Si è soliti individuare questo cambiamento con il riferimento generico e omnicomprensivo di “Post-human”, anche per l’impatto della narrativa cyberpunk degli anni ’80 e della metamorfosi dell’estetica e della produzione artistica nel decennio successivo, a indicare un superamento dell’antropoplastica vitruviana – basata su una corporeità metrico-sussuntiva dell’umano capace di proiettarsi sul mondo esterno – barattata dall’immagine dell’ibrido, del mutante, del transcorporeo. A ben vedere, tuttavia, fin dal suo esordio, l’icona-condizione del postumano nascondeva punti di vista assai differenti e per certi versi inconciliabili.
L’evoluzione tecnologica della seconda metà del Novecento ha indubbiamente modificato in modo profondo non solo la prassi – vale a dire il prospetto operativo nelle diverse attività produttive e nella percezione delle aspettative di confort e di performatività – ma altresì il modo di interpretare la dimensione umana e le coordinate di antropo-poiesi. Si è soliti individuare questo cambiamento con il riferimento generico e omnicomprensivo di “Post-human”, anche per l’impatto della narrativa cyberpunk degli anni ’80 e della metamorfosi dell’estetica e della produzione artistica nel decennio successivo, a indicare un superamento dell’antropoplastica vitruviana – basata su una corporeità metrico-sussuntiva dell’umano capace di proiettarsi sul mondo esterno – barattata dall’immagine dell’ibrido, del mutante, del transcorporeo. A ben vedere, tuttavia, fin dal suo esordio, l’icona-condizione del postumano nascondeva punti di vista assai differenti e per certi versi inconciliabili.
Si tratta di una galassia d’interpretazioni che, per approssimazione, possiamo afferire a due grandi filoni di pensiero: i) chi considera la condizione postumana come una meta da raggiungere o, viceversa, quale inevitabile sbocco-deriva di un tracciato inaugurato con la rivoluzione scientifica del XVII secolo, con l’illuminismo e infine con la rivoluzione industriale nelle sue tre fasi implementative, per cui occorre parlare di una transizione in essere e paradigmatica, definibile per l’appunto come transumanismo; ii) chi considera la condizione postumana come implicita nella costruzione dei predicati umani, perché da sempre l’uomo si è ibridato attraverso utensili e tecniche con il non-umano, per cui si rende necessario un cambiamento nel paradigma interpretativo rispetto all’umanismo tradizionale, vale a dire una filosofia postumanista. Esistono dei punti in comune tra le due proposte, tali per cui si possa parlare di un movimento di pensiero omogeneo che caratterizza il XXI secolo? Direi di sì, ma si contano sulla punta delle dita e, a ben vedere, sono molte di più non solo le differenze, ma le aree di contrasto e opposizioni tra queste due prospettive.
Il transumanismo è, in effetti, un’evoluzione dell’umanismo: in linea con l’imperativo di accentuare la titolarità dell’uomo sul proprio destino, in una visione spesso – ma non sempre – antropocentrica, fortemente razionalista e prometeica nell’individuazione della poetica umana, in genere poco attenta alla filosofia europea del Novecento e alla critica all’umanismo, portata a considerare la tecnologia non come strumento bensì come un amnios contenitivo e salvifico, apparentemente pragmatica nell’ottimismo operativo e nella fiducia verso l’ingegno umano, propensa a traghettare le icone tradizionali del monoteismo – l’immortalità, gli angeli, l’incorporeo e il postorganico – in una sorta di neopaganesimo e di immanentismo spirituale, con una predisposizione al sincretismo, che per molti versi ricorda il movimento new age e ne rivela la matrice culturale e geopolitica di derivazione, declamante una specie di universalismo edonistico e atarassico, ma al contempo non estranea ad appoggiarsi ai magnati del capitalismo contemporaneo e a sostenere obiettivi a medio-lungo termine chiaramente tesi a delineare politiche ultraliberiste e differenze accentuate di condizione.
Possiamo sempre ritrovare in modo uniforme, o in veste di comuni denominatori, tali dettati? Ovviamente no, perché il transumanismo è un vasto arcipelago di declinazioni, alcune incentrate sul desiderio di persistenza e sull’empito di potenza, altre più attente alla sofferenza e al principio di piacere universale: le prime più vicine al pensiero nietzschiano, le seconde più riflessive sulla domanda di Jeremy Bentham “possono soffrire?”. Tuttavia un mare comune, potremmo dire un milieu condivisivo, lega fra loro le diverse proposte transumaniste, che potremmo inquadrare in una sorta di professione di fede nel progresso e nella tecnoscienza che, a mio avviso, risentono di un retrogusto schopenhaueriano. Caduta la fede in una dimensione di trascendenza assoluta, un aldilà non sovrapponibile alla condizione terrena, i transumanisti scommettono ora in una sorta di trascendenza relativa, un aldiquà sempiterno in grado di soddisfare il languore temporale ed edonico. In questo senso il transumanismo ricorda una specie di tecno-religione, giacché gli obiettivi di conforto e cura dell’anima sono a ben vedere gli stessi.
Il mondo contemporaneo, nei paesi occidentali, par essere un desco imbandito per un pranzo luculliano ove nessuno è propenso ad allontanarsi da tavola, anche quando il tempo è scaduto, per cui sembra che non si possa essere lieti se “di doman non c’è certezza”: alla tecnoscienza il compito o la chimera di cancellare il fastidioso “memento mori”, decaduto nel suo significato di avvertenza nel bugiardino della vita. Curiosamente, a dispetto delle trasfigurazioni postorganiche e incorporee, delle proiezioni visionarie di esistenze nella rete, di fusioni al silicio con macchine soft metal, le riflessioni transumaniste trasudano di carne languida di metabolismi, di espressioni limbiche – quali l’entusiasmo, l’eccitazione, la gioia, il piacere – che si realizzano solo grazie alla neuromediazione endocrina di pancreas, gonadi, surrenali, di percezioni che non sarebbero pensabili senza il frattalico elaborativo di un corpo. In altre parole, non è possibile aspirare al piacere somatico desomatizzando l’esistenza, giacché la neurobiologia-fisiologia non può essere ricondotta a mere sollecitazioni di aree del cervello. Da qui una prima incoerenza nel lessico transumanista: ondivago e ambivalente tra la ricerca superorganica del piacere e la proiezione emancipativa dall’organico.
D’altro canto, questa focalizzazione sul corpo – desiderato, inquisito, rimosso – una sorta di riproposizione della danza primaverile botticelliana, con la tecnoscienza quale novello Hermes, ci riporta a quanto detto sulla contiguità del transumanismo con alcuni aspetti dell’umanismo primigenio, e non è un caso se l’immagine a logo di Leonardo da Vinci dell’Uomo vitruviano torna in auge, seppur con i dovuti rimaneggiamenti futuristici. C’è pertanto una stretta relazione interpretativa tra questa prospettiva e il pensiero dei primi umanisti – penso al manifesto pichiano o all’universalismo di Marsilio Ficino – e del neoumanismo romantico e positivista – da Max Scheler ad Arnold Gehlen – perché anche nel transumanismo assistiamo a quell’empito di verticalizzazione dell’umano: i bruti non sono più rappresentati dagli animali, ma dalla condizione stessa dell’essere umano. Nell’ascensione verticale tecnomediata, l’uomo cerca così di liberarsi dagli ultimi legacci del retaggio filogenetico, per aspirare a una condizione capace di trascenderne in modo radicale, e non solo compensativo-esonerativo, i limiti temporali e nocicettivi.
In questo senso, non è possibile ignorare l’impostazione iperumanistica – da non confondere con l’accezione “sovraumanistica” – delle narrazioni, delle icone e delle proposte transumaniste. Diciamo che si tratta di un portare a massimo regime, ovvero a cercare nella tecnologia la declinazione possibile, alle aspirazioni dettate da Pico della Mirandola nel “De hominis dignitate” e che trovano risonanza nella verticalizzazione antropotecnica proposta da Peter Sloterdijk. Ovvio che il passaggio, da una traduzione filosofica del “proprio dell’umano” – quale ascensionalità e disgiunzione che accomuna – a una lettura più di ordine sociale, derivale, nella distinzione all’interno dell’umano stesso, può essere pretestuoso. Ma attenzione: non necessariamente difficile o incoerente. Il sovraumanismo può essere rigettato e ritengo vi siano autori che in buona fede ritengano sbagliato seguire tale strada o confonderla sovrapponendola al transumanismo. Tuttavia non è possibile ignorare gli esiti inevitabilmente sovraumanisti dell’eugenetica e dell’algenia, dell’accesso differenziale alle tecnologie di punta, dell’aumento della forbice tra ricchi e poveri implicito nel turbocapitalismo tecnologico, dell’incremento del potere mediatico di pochi, della disgiunzione nelle prassi lavorative tra persona e attività… e sono solo pochi esempi.
Altro punto di forte contiguità con l’umanismo – e sottolineo, in una straordinaria uniformità che accomuna i primi umanisti ai teorici dell’antropologia filosofica novecentesca, ma che riprende il mito greco della doppia genealogia prometeica ed epimeteica degli animali – vi è nel transumanismo la pretesa di una lettura proteica e virtuale della condizione umana, che sembra saltare a piè pari tanto l’evoluzionismo darwiniano quanto l’etologia. Sostenere che l’essere umano sia una sorta di contenitore skinneriano che può essere mutato in qualunque foggia a seconda dell’innesto tecnologico inserito, rappresenta indubbiamente un’ingenuità, che mostra come il pensiero evoluzionista abbia ancora tanta strada da fare nel continente americano. Non potremmo mai tramutarci in anodini contenitori di tecnologia, bensì declinare la nostra natura attraverso la tecnologia: la differenza c’è ed è rilevante! Certo, la tecnologia non è un vestito, ma da qui a farne una matrice morfopoietica ne corre. Dovremmo utilizzare una prospettiva dialettica, ovvero autenticamente ibridativa, perché l’essere umano non è acqua che può assumere la forma del contenitore.
Quando rimarco le risonanze umanistiche del pensiero transumanista, prendo per esempio in considerazione il ritrovare il dualismo cartesiano dell’avere-un-corpo, nel barattare la res-cogitans con la res-informatica, dimentichi di tutte le ricerche di fisiologia, e in particolare di neuroimmunoendocrinologia che dimostrano spinozianamente che “siamo-un-corpo”. L’idea di superare la sofferenza e la morte ha indubbiamente un suo fascino – non a caso è sempre stato questo il cavallo di battaglia di ogni religione – e il porre tale immortalità nel qui-e-ora accontenta tutta quella umanità che nel qui-e-ora banchetta sulle spalle dei poveri del mondo. Ma ciò ha, non dico un senso ma, anche più semplicemente, una qualche plausibilità? Per i transumanisti è una professione di fede e come tale – come in buona parte delle religioni – per ora accontenta il portafoglio dei potentati di turno che vedono incrementare i loro investimenti. Tuttavia alcune proposte, come il mind-uploading o l’ingegneria proteica finalizzata a riprogrammare morfologicamente l’essere umano si basano su assunti scorretti. Da qui lo strano paradosso: nel celebrare i fasti della tecnoscienza, sovente i transumanisti fanno un cattivo lavoro per la ricerca sia perché spacciano illusioni che a lungo andare procurano il mitridatismo, sia perché fomentano il sensazionalismo e di conseguenza il reflusso, la sindrome di Frankenstein, la lettura luciferina dello scienziato.
Ma, a dir il vero, è il senso che mi sembra ancor più deficitario in tutta questa enfatizzazione del luna park tecnologico e lo dico come studioso che crede nel valore educativo della scienza e che rifugge da forme di veteroluddismo. Non è possibile guardare in modo acritico lo sviluppo tecnologico, disconoscere il fatto – se vogliamo banale – che ogni tecnologia implicita rischi e opportunità, vale a dire li inerisce al di là del modo specifico in cui viene utilizzata. Questo peraltro è l’aspetto più contraddittorio del pensiero transumanista: da una parte si declama la transizione, l’umano metamorfico nella capsula Petri della tecnosfera, dall’altra si pretende di mantenere tale mutante embrionale alla cabina di comando e ci si appella ancora allo specchietto per le allodole che ripete il mantra del “tutto sta a come si utilizza una tecnologia”. Se è vero il principio transumanista della transizione, non è corretto ritornare al principio umanistico del controllo, perché non c’è più un’essenza predicativa capace di offrirmi un orientamento, seppur generico, sul fatto di rimanere alla regia dell’utilizzo e, nel caso ciò avvenisse, nel modo in cui espliciterà tale utilizzo.
A dir il vero, alcuni teorici transumanisti glissano per onestà su questo aspetto dell’umano timoniere di techne, penso alle proiezioni di Vernor Vinge e di Ray Kurtzweil. Già, perché se è vero che la singolarità toglierà all’umano la regia, allora qualunque proiezione non solo è un azzardo, ma finisce per dar luogo a un non-senso. La differenza tra l’umanismo tradizionale e il transumanismo sta proprio nella decadenza di un qualunque ordine fondativo e quindi nell’aleatorietà di qualsivoglia proiezione predicativa sul futuro. Non si può infatti parlare di futuro dell’essere umano senza un punto d’appoggio sull’essere umano stesso. Di cosa staremmo parlando? L’umanismo classico – quello del vitruviano, per intenderci – costruiva il suo universalismo attraverso l’antropoplastica, poteva cioè trasformarsi in progetto mondano perché utilizzava come unità di misura l’anatomia somatica dell’uomo e come fondale contenitivo l’insieme dei predicati umani. Se tanto la metrica quanto la sussunzione decadono, crolla inevitabilmente il progetto di verticalizzazione dell’umano: in altre parole, non è possibile soddisfare il manifesto pichiano mettendo in dubbio il logo di Leonardo.
È, a tal riguardo, utile distinguere nettamente l’impostazione postumanista rispetto alla tradizione umanistica, basata su una concezione di umano pensabile iuxta propria principia ovvero estraibile per ricognizione interna, giacché ritenuto autarchico, autopoietico e impermeabile rispetto al non-umano. Lo slittamento ermeneutico proposto dalla filosofia postumanista può essere definito come una metamorfosi interpretativa dell’ontologia umana in opposizione alla lettura antropocentrica dell’umanismo, in particolare rispetto a due aspetti fondamentali: i) la lettura dei predicati umani, intesi come frutti ibridi e non come espressioni emanative o di discendenza diretta di una presunta essenza umana; ii) la lettura della creatività, intesa non in modo antropoplastico, ma come esito di un’epifania o costruzione di un nuovo piano di realtà. Come si vede, possiamo rinvenire una comunanza rispetto al transumanismo nell’enunciazione, ossia nella consapevolezza, di una concezione ibrida del predicato umano, e parimenti nella visione transitoria e transitiva, ossia ontopoietica e non solo ontogenetica, della condizione umana.
Diciamo che tanto il transumanismo quanto il postumanismo considerano la condizione umana non quale antropopoiesi correlativa o compensativa, come si riscontra per esempio nell’antropologia filosofica di matrice neoumanistica, ma in termini di apertura dialettica o “antropopoiesi ecologica”, per cui il predicato umano è solo parzialmente indirizzato dall’umano ma risulta, per altri versi, aperto all’occasionalità dell’incontro con l’alterità. In tal senso anche il supporto tecnologico non viene considerato in termini di: i) ancillarità, vale a dire nel porsi al servizio di finalità umane a-priori, bensì in termini di managerialità ovvero di istituzione-emergenza teleologica; ii) esonero, vale a dire di surrogazione rispetto a una chiamata in causa performativa, bensì di ingaggio, inteso come un’istruzione di compiti da assumere; iii) compensazione di una carenza-incompletezza a-priori della natura umana, bensì di languore, vale a dire di costruzione di nuovi bisogni; iv) ergonomia, come se la tecnica si adeguasse al corpo, bensì di metaplasia ovvero è la techne che adegua il corpo; v) disgiunzione, nel vedere la techne come una guanto che separa il corpo dal mondo e lo mantiene puro, bensì come fattore di congiunzione; vi) potenziamento, o azione probiotica della techne, bensì in termini di azione virale o mutagena sui predicati.
Tuttavia, a parte questi aspetti, nondimeno importanti e che segnano un indubbio cambiamento di paradigma nel pensiero contemporaneo, rilevanti sono le differenze tra le due impostazioni. Lo ripeto, perché spesso si confonde la filosofia postumanista con il transumanismo, per il fatto che entrambi fanno riferimento a una condizione postumana, per quanto con profonde differenze giacché: mentre per il transumanismo è postumano ciò che si verrà a realizzare nel passaggio tecno-metempsicotico dell’umano, per il postumanismo siamo sempre stati postumani, in quanto entità ibride. Per il postumanismo oggi semplicemente occorre avere maggior contezza della nostra natura ibrida e del fatto che nell’ibridazione non si assiste a una disgiunzione e a un’emancipazione bensì il contrario: l’ibrido è molto più congiunto, dipendente e bisognoso delle alterità. L’ibridazione ricorda la costruzione di nicchie negli esseri viventi che, se è vero che slitta pressioni selettive dal corpo in sé, ugualmente libera le pressioni selettive sull’adeguatezza alla nicchia, ovvero sulla dipendenza di quella specie dal suo mondo.
Mentre il transumanismo sottolinea l’empito di verticalizzazione dell’umano, non discostandosi da quel progetto pichiano di ascensionalità, per il postumanismo è indispensabile mettere a fuoco il processo di orizzontalizzazione ontopoietica dell’umano e il bisogno crescente di alterità che l’antropopoiesi implica. C’è nel transumanismo un non detto di autonomia, individualità, autosufficienza, egocentrismo – fino a spingersi a una sorta di egoteismo – contro cui, viceversa, la filosofia postumanista, memore della ricerca esistenzialista, fenomenologica, decostruzionista del Novecento, ci mette in guardia, soprattutto in considerazione delle grandi crisi ecologiche e geopolitiche in atto. Il grande tema dell’alterità sta al centro della filosofia postumanista, sottolineando come l’individualismo e il consumismo siano i veri attori eziopatogenetici dei problemi del nostro tempo. Il rischio che io rilevo in un transumanismo incapace di riflettere sulle alterità e di mitigare gli eccessi iperumanistici è, viceversa, quello di puntare tutto proprio su questi due fattori, andando a incentivare non solo le problematicità del nostro tempo, ma anche quella sofferenza dell’individuo che non deriva dal memento mori ma dall’incapacità di trovare un senso nella gravitazione solipsistica e narcisistica egocentrata.
Roberto Marchesini
lunedì, Febbraio 23, 2026