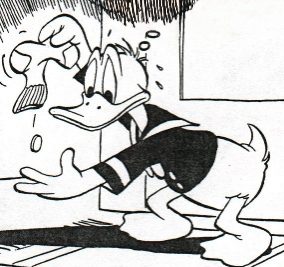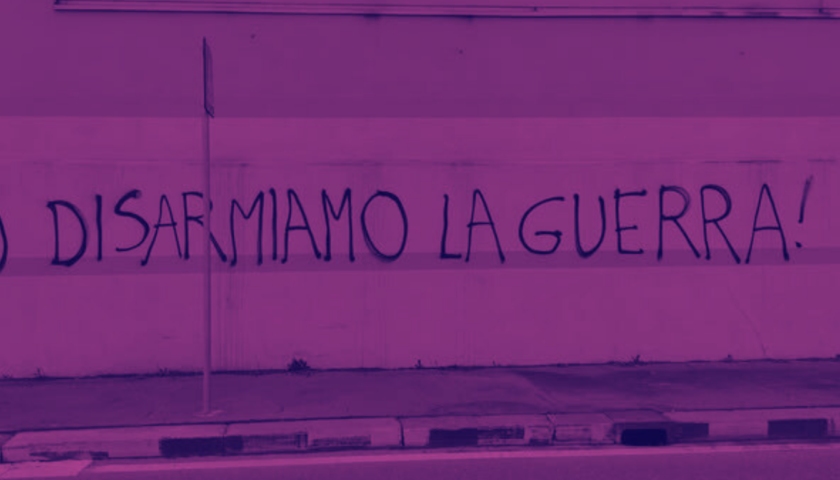In queste righe si opererà un’analisi di estrema realpolitik, guardando al dato economico nudo e crudo per poter capire cosa succede e cosa c’è da aspettarsi nell’immediato futuro. L’analisi economica è essenziale per comprendere la complessa fase del capitale in questo periodo. Al di là di speculazioni tra mondo unipolare e multipolare, l’unica aggettivazione che non sembra trovare spazio in molte dissertazioni lette e nelle varie tifoserie da stadio fra rossobruni e “medio progressisti” in cerca d’autore è quella di imperialismo. La lotta in atto in questa fase storica non è per aprire i mercati a più competitors garantendo una globalizzazione plurale, ma è in atto uno scontro tra tendenze imperialiste e l’Europa nella migliore delle ipotesi fa da pivot, nella peggiore è territorio di caccia.
Parlando degli USA Il panorama internazionale del gennaio 2026 ha definitivamente sollevato il velo sulle reali intenzioni della proiezione imperiale statunitense, trasformando quella che un tempo era chiamata “globalizzazione” in una spietata azione di sopravvivenza nazionale. All’interno delle “leggi” che strutturano la natura intrinsecamente predatoria del capitalismo globale, la necessità del reshoring americano non nasce da un’improvvisa vocazione sociale verso la propria popolazione, ma da un’urgenza bio-politica di mettere in sicurezza i flussi materiali della produzione.
La dottrina che abbiamo visto consolidarsi sotto la spinta dell’accelerazione “trumpiana” — un termine che ormai definisce non solo un uomo, ma un metodo di gestione muscolare dell’egemonia — ha ampiamente superato la fase soft dei dazi, per entrare in quella dell’appropriazione manu militari delle risorse. Il reshoring non è più un invito alle aziende a rientrare, ma una coercizione strutturale attuata tramite la creazione di un ecosistema industriale esclusivo, dove l’accesso all’energia e alle materie prime è garantito solo a chi accetta di ricollocarsi entro i confini protetti dell’enclave americano.
In questo quadro, l’operazione in Venezuela del 2026 non è un capriccio del tycoon, né un’operazione per eliminare un regime o un rigurgito di guerra fredda, ma un atto necessario di un processo di difesa del potere statunitense in cui la logica del controllo dei flussi energetici prevale su qualsiasi protocollo diplomatico. Il controllo delle riserve venezuelane risponde alla necessità materiale delle raffinerie della Gulf Coast, tecnicamente progettate per il greggio pesante estratto in Venezuela. Ma serve soprattutto a recidere il cordone ombelicale dello schema “oil-for-debt” che legava Caracas a Pechino.
Il controllo del Venezuela non serve quindi per abbassare il prezzo alla pompa per il cittadino del Nebraska, ma per dominare la catena del valore della chimica di base. L’industria europea, in particolare quella tedesca e italiana, è costruita sulla trasformazione. Senza gli idrocarburi pesanti l’Europa è ferma. Sottraendo il greggio venezuelano al mercato globale, gli USA hanno creato un differenziale di costo insostenibile. Mentre le raffinerie americane lavorano molecole “proprietarie” a basso costo, le aziende europee devono rivolgersi a mercati spot volatili o a fornitori geopoliticamente rischiosi.
L’intervento in Venezuela ha quindi inaugurato la fase del “sequestro preventivo” dei nodi della supply chain. Gli USA hanno capito che la guerra egemonica con la Cina non si vince in borsa, ma nell’accaparramento delle risorse con l’occupazione di miniere e pozzi. L’affaire Venezuela — occupazione dello spazio strategico e negazione della risorsa al competitor — è da considerarsi come il “modello” che verrà applicato al triangolo del litio in Sud America (Argentina, Cile, Bolivia) e ai giacimenti di cobalto e terre rare in Africa. Si tratta in definitiva di un’azione di negazione delle risorse, che trasforma l’energia da merce a strumento di guerra asimmetrica: sottraendo il petrolio venezuelano al mercato asiatico, gli Stati Uniti non solo stabilizzano i costi interni della propria manifattura, ma aumentano esponenzialmente i costi di produzione dei competitors, rendendo di fatto per i cosiddetti partners, il reshoring l’unica opzione di sopravvivenza per il capitale occidentale. Oppure, alle brutte, orientare gli acquisti verso occidente invece che ad oriente.
Questo non è un libero mercato (se mai fosse esistito); è un monopolio dell’input. Se controlli la molecola di base, controlli il prezzo finale di ogni componente plastico, farmaceutico o tecnologico prodotto in Europa. Il reshoring americano si nutre della deindustrializzazione europea: non potendo competere sul costo della materia prima, le aziende chimiche UE sono costrette a delocalizzare proprio negli Stati Uniti per sopravvivere.
L’accelerazione trumpiana ha impresso una velocità inedita a questo processo, eliminando le mediazioni multilaterali intraprese da Obama e Biden a favore della forza bruta che agisce direttamente sulle infrastrutture critiche degli avversari. Se la Cina ha tentato nei decenni precedenti di agganciare l’Occidente attraverso la “Nuova Via della Seta”, gli Stati Uniti hanno risposto smantellandone i terminali energetici in Sud America, dimostrando che nell’era del realismo delle catene del valore, un pozzo di petrolio sotto controllo militare vale più di mille trattati commerciali.
Il significato di queste azioni nello scenario globale è il ritorno a un mercantilismo armato nel quale la moneta mercantile, il dollaro, torna a essere garantita non più solo dalla fiducia, ma dal controllo diretto e militare delle risorse primarie. È la fine del mantra pluridecennale di un mercato globale libero e neutrale, già di per sé assolutamente irreale. Il risveglio dall’allucinazione del libero mercato oggi ci dice una volta di più che il controllo geografico conta più della finanza, e la vicinanza fisica ad una fonte di approvvigionamento protetta è l’unico reale vantaggio competitivo rimasto.
In questo gioco a somma zero, la Cina si ritrova con miliardi di cartastraccia in crediti inesigibili e una “flotta ombra” di petroliere sequestrate, attualmente impegnata a cercare ritorsioni sul fronte delle terre rare. Ritorsioni che non riguardano i soli Stati Uniti ma anche i suoi alleati/acquirenti. Le terre rare giocano un ruolo da comprimarie alla stregua degli idrocarburi. Non è un caso che Trump stia facendo di tutto per mettere le mani sulla Groenlandia e nel contempo stia mercanteggiando sul conflitto ucraino e le terre rare sotto i territori contesi.
Si sta innescando una spirale di blocchi incrociati che sta portando il commercio mondiale alla paralisi. Questa frammentazione non è un errore del sistema, ma una nuova configurazione: la creazione di blocchi industriali autosufficienti e contrapposti, dove ogni risorsa sottratta all’avversario è una vittoria tattica nella guerra per il primato tecnologico del XXI secolo. L’Europa, in questo scontro, appare come il soggetto più vulnerabile. La scommessa accelerata sulla transizione energetica, attuata senza alcuna indipendenza estrattiva o tecnologica, ha consegnato il settore automotive — e il relativo indotto chimico e meccanico — alla concorrenza asiatica.
Il dogma dell’elettrico ha ignorato i cicli materiali, portando l’industria a un punto di rottura nel quale l’energia è diventata un lusso insostenibile. Il tentativo di compensare questo declino con un riarmo accelerato ha come risultato un mercato drogato: un sussidio temporaneo alla meccanica pesante che non risolve il vuoto di competitività. Il pericolo reale è un decoupling inverso: un’Europa schiacciata tra il protezionismo americano, l’aggressività asiatica e la scomoda vicinanza russa.
Da un lato l’industria UE ad alto potenziale tecnologico è tentata dai sussidi dell’Inflation Reduction Act (IRA) di Biden. Dall’altro, la ritorsione cinese che agisce sui minerali critici, colpendo alla base la follia della transizione verde europea proprio nel momento in cui la crisi energetica legata al conflitto russo-ucraino ha reso insostenibili i costi di produzione tradizionali. Il terzo incomodo, la Russia, è un vicino diventato scomodo in seguito all’aggressione ai danni dell’Ucraina, ma che in tempi non sospetti non era considerato poi tanto male, fintanto che forniva energia a buon mercato.
Consideriamo per un attimo le implicazioni dell’IRA, che è un piano di salvataggio del solo ecositema produttivo USA, un’operazione di pirateria industriale. Il meccanismo dei crediti d’imposta e dei sussidi diretti è studiato per essere “esclusivo”: ricevi fondi solo se la produzione e, soprattutto, la ricerca avvengono su suolo americano.
Questo sta provocando una migrazione silenziosa ma massiccia dei reparti R&D (Ricerca e Sviluppo). Le eccellenze europee nell’idrogeno, nelle batterie e nei nuovi materiali non vendono più solo il prodotto agli USA; spostano lì interi laboratori per accedere ai miliardi di dollari del Tesoro americano. L’ambivalenza è feroce: gli USA si presentano come i leader della transizione ecologica, ma lo fanno drenando il capitale intellettuale dei propri alleati. L’Europa si ritrova a pagare i costi della formazione dei propri ingegneri per poi regalarne i frutti al sistema produttivo americano. È un saccheggio legalizzato dettato da logiche di mercato dopate.
In questo quadro di imperialismi concorrenti, la dipendenza europea dal sistema finanziario e militare statunitense si trasforma in una trappola. Ogni successo del reshoring americano è un chiodo nella bara della manifattura europea. Se il fossile e il chimico tornano a essere una prerogativa di controllo di Washington, l’Europa si ritrova a dover scegliere tra l’irrilevanza produttiva o la totale sottomissione politica. La “fortezza industriale” americana non prevede alleati alla pari, ma solo sub-fornitori o colonie tecnologiche. La partita del 2026 non si gioca sui dazi, ma sulla capacità di controllo fisico delle molecole e degli elettroni; una partita in cui l’Europa, priva di una visione strategica propria, rischia di essere il tavolo su cui gli altri giocatori si spartiscono i resti.
JR