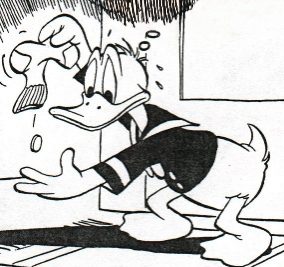“Fino a quando sarà la ricchezza, e non la virtù, a rendere l’uomo rispettabile, si perseguiranno prima le ricchezze della virtù; e finché si carezzeranno i corpi di donne i cui sciocchi sorrisi infantili mostrano assenza d’intelletto, la mente rimarrà incolta”.
Questa citazione è estratta da A vindication of the rights of woman, un titolo che in diverse edizioni è stato tradotto in italiano Sui diritti delle donne. Credo invece che sia cruciale porre l’accento proprio su questa vindication: siamo di fronte a un’opera che non è soltanto un asettico trattato “sui diritti delle donne”, ma una vera e propria rivendicazione. Rivendicare significa prima di tutto riconoscere, per poi riaffermare e riappropriarsi di qualcosa – innanzitutto, dei diritti. Dal punto di vista illuminista dovrebbero essere di tutti, da quello protofemminista e “metailluminista” di Wollstonecraft di tutti e di tutte: solo quando lo saranno scopriremo – sentite la provocazione – se la donna sarà “compagna dell’uomo o sua schiava”; fino a quel momento ogni mancanza è una sottrazione, un furto, una limitazione dell’espressione e formazione dell’individuo che impedisce di scoprire le infinite possibilità percorribili dalle donne e da, oggi aggiungeremmo, tutti i “secondi sessi”.
Wollstonecraft ha in mente innanzitutto il diritto all’istruzione: la mancanza di un’educazione adeguata e ordinata è il fattore primario che “rende […] schiave le donne, atrofizzandone l’intelletto ed eccitandone i sensi”. Quella riservata alle sue contemporanee viene definita un’educazione disordinata, che con la sua precarietà impedisce di sviluppare capacità di generalizzazione e astrazione, incatenando le donne alla schiavitù dell’abitudine. Mi viene in mente la fine che farà l’ingenuo tacchino induttivista di Russell e Popper – tacchino che, ricevendo cibo ogni giorno alla stessa ora e basandosi su un ragionamento induttivo per enumerazione, si culla nella certezza del nutrimento, salvo poi venire ucciso alla vigilia di una festa in cui sarà proprio lui la portata principale.
Le donne vengono così mantenute in una condizione di “ignoranza camuffata da innocenza” – un inganno, che la sagace Wollstonecraft sottolinea a più riprese. Come sintetizzato nella citazione di apertura, finché l’ingenuità e la mansuetudine femminili saranno ben viste, queste attitudini – spacciate per “naturali” – non solo non verranno problematizzate, ma continueranno a risultare accettabili o perfino desiderabili anche dalle donne stesse.
L’ignoranza femminile è funzionale, naturalmente, al mantenimento delle donne in una posizione di sottomissione e dipendenza dagli uomini. Se Kant nel 1784 poteva rispondere alla domanda “Che cos’è l’illuminismo?” scrivendo che esso è “l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso”, nella Vindication del 1792 viene affermato con forza che il mantenimento delle donne in uno stato di minorità è imputabile a un’intera società che ha tutto l’interesse nell’impedire loro di emanciparsi – una società che vede, tra le altre, donne costrette a rendersi astute usando strategie di sopravvivenza che, quand’anche non umiliassero, comunque rafforzano lo status quo. Wollstonecraft pensa, per esempio, alla sessualità al servizio della gerarchia, alla bellezza ammaliatrice come illusorio ed effimero potere, alla frivolezza come occupazione a tempo pieno o quasi (per le borghesi però!). Che siate d’accordo o no, le sue argomentazioni sono ammirevoli per il loro rigore logico e per la modernità del loro contenuto. Ce lo dirà anche Naomi Wolf nel 1990: «Prima ancora delle incursioni del movimento femminista nel mercato del lavoro, sia gli uomini sia le donne si erano abituati al fatto che la bellezza fosse valutata come ricchezza [nel mercato del matrimonio]. Erano entrambi preparati alla clamorosa evoluzione che sarebbe seguita: mentre le donne richiedevano l’accesso al potere, la struttura del potere si serviva materialmente del mito della bellezza per minare l’avanzata delle donne». Il Mito della Bellezza come teorizzato da Wolf si rafforza e mostra tutta la sua violenza a partire dal secondo dopoguerra, ma se è stato così efficace come strumento di (bio)potere è soprattutto perché era già ben radicato: la sua microfisica coinvolge non solo il nostro corpo ma anche la nostra intimità, autostima, interiorità. Un’interiorità costruita in secoli di continui tentativi di inferiorizzazione coatta che – anche nel suo servirsi della trappola della bellezza – ha agito sulle donne come genere e come singole. In un passo che sarebbe interessante porre in dialogo con gli studi di Elena Gianini Belotti e Maria Montessori, l’autrice di A Vindication osserva infatti che “Sin dall’infanzia viene insegnato [alle bambine] che la bellezza è lo scettro della donna; la loro mente si modella sul corpo e, ciondolandosi nella gabbia dorata, cerca solo di venerare la propria prigione”.
Ma, tornando alla citazione di apertura, a ben vedere essa tocca anche un altro tema: il rapporto tra ricchezza e virtù. Non si tratta di una forzatura argomentativa. Per approfondire e comprendere meglio la posizione di Wollstonecraft, propongo la lettura di un altro e più lungo passo.
“Dal rispetto tributato alla proprietà derivano, come da una fonte avvelenata, la maggior parte dei mali e dei vizi che rendono questo mondo una scena cupa per le menti contemplative. […] Una classe sociale fa pressione sull’altra, perché tutte mirano a procurarsi rispetto sulla base della proprietà, e la proprietà, una volta ottenuta, procura quel rispetto che si dovrebbe soltanto ai talenti e alle virtù. Gli uomini trascurano i doveri e tuttavia sono trattati da semidei. […] Ci deve essere maggiore uguaglianza nella società, altrimenti la moralità non guadagnerà mai terreno e la moralità virtuosa non avrà solidità neanche se impiantata sulla roccia; finché una metà dell’umanità resterà incatenata alla sua base, la virtù sarà sempre minacciata dall’ignoranza e dall’orgoglio. È vano aspettarsi la virtù dalle donne finché esse non saranno, in qualche misura, indipendenti dagli uomini; è vano aspettarsi quella forza dell’affetto naturale che le renderebbe buone mogli e madri. Finché saranno assolutamente dipendenti dai mariti, useranno l’astuzia, saranno meschine ed egoiste. […] Il rispetto tributato alla ricchezza e al fascino personale è […] una vera tempesta polare che fa appassire i teneri fiori dell’affetto e della virtù”.
Al di là della severità del giudizio sulle sue con-generi: che fare, quindi? Ridistribuire la proprietà privata, cercare l’emancipazione dall’uomo? Oppure abolirla, la proprietà privata, e cercare di liberarsi insieme? Forse queste domande vanno oltre la teorizzazione di Wollstonecraft, che comunque lega strettamente l’emancipazione delle donne all’indipendenza dagli uomini e dalla proprietà (maschile?): emerge dai suoi scritti l’idea che finché ci sarà la proprietà ereditaria persisteranno vincoli sociali, culturali ed economici che non potranno mai rendere la donna davvero libera. E neanche l’uomo.
Wollstonecraft infatti non dimentica la stratificazione di classe che pervade e in-forma l’intera società e parlando della questione della rappresentanza politica afferma: “credo davvero che le donne debbano avere dei rappresentanti invece di essere governate arbitrariamente senza alcuna voce di capitolo nelle delibere del governo. Ma giacché l’intero sistema di rappresentanza in questo paese è solo una comoda occasione di dispotismo, le donne non dovrebbero lamentarsi del fatto che sono rappresentate nella stessa misura in cui lo è la numerosa classe di operai, lavoratori accaniti che pagano per il sostentamento dei membri della famiglia reale quando riescono a stento a saziare con il pane la bocca dei figli. Come vengono rappresentati coloro il cui stesso sudore serve a mantenere la splendida scuderia di un erede diretto, o fa da ornamento al cocchio di qualche favorita che rivolge sguardi sprezzanti alla miseria?”.
Insomma, vogliamo essere libere davvero? Allora liberə tuttə!
Mary Wollstonecraft è nata a Londra nel 1759 e morta il 10 settembre del 1797 quando sua figlia Mary, la futura celeberrima Mary Godwin Shelley autrice di Frankenstein, aveva solo una decina di giorni. Nel 1790 ha pubblicato A Vindication of the rights of Men, nel 1792 A Vindication of the rights of Woman. Nel 1797 stava scrivendo Mary, or the wrongs of woman. Nonostante le riflessioni sulla proprietà, A Vindication è considerato il manifesto del femminismo americano e inglese di stampo liberale. L’opera venne aspramente criticata dai conservatori, probabilmente appartenenti loro stessi a quella schiera di “uomini che, ansiosi di rendere le donne amanti seducenti piuttosto che mogli fedeli e madri razionali, hanno guardato a loro come femmine e non come esseri umani”.
Noi oggi andiamo oltre e vogliamo essere – prima ancora che amanti, mogli o madri – semplicemente noi stesse. Libere e insieme.
Serena Arrighi
Gruppo Germinal Carrara