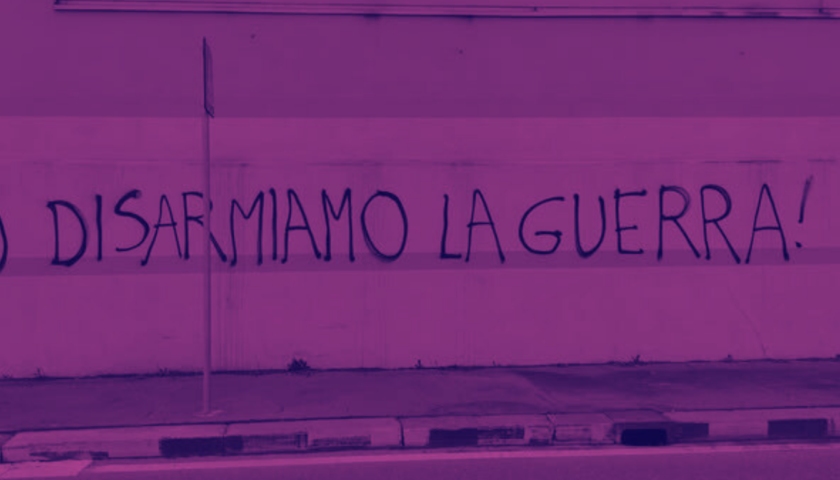Uno dei luoghi comuni più forti, almeno a mio avviso, nell’ambiente libertario è quello per cui, nel momento in cui ci si propone e si propone sul piano teorico/pratico una critica radicale dell’esistente, è necessario avere una proposta o, se si preferisce, una prefigurazione di una possibile società superiore.
Uno dei luoghi comuni più forti, almeno a mio avviso, nell’ambiente libertario è quello per cui, nel momento in cui ci si propone e si propone sul piano teorico/pratico una critica radicale dell’esistente, è necessario avere una proposta o, se si preferisce, una prefigurazione di una possibile società superiore.
Vi è una sorta, quindi, di horror vacui per il quale si può essere “rivoluzionari” eticamente e politicamente corretti solo se si è in grado di proporre o, meglio ancora, prefigurare forme di produzione e di relazioni sociali compiutamente libertarie.
Con ogni evidenza, basta pensare alla robusta tradizione del socialismo utopistico nella prima metà del XIX secolo, il bisogno di prefigurare una società superiore non è una novità.
Vi è però una motivazione specifica delle prefigurazioni attuali che non va, a mio avviso, sottovalutata: nel secolo scorso le rivoluzioni che effettivamente si sono date e che, come capita alle rivoluzioni che effettivamente si danno, sono state sorprendenti, confuse, contraddittorie, hanno avuto esiti straordinariamente difformi rispetto alle aspettative di coloro che avevano teorizzato la rivoluzione nel XIX secolo.
Di questo scacco si possono dare diverse spiegazioni anche perché non di una sola “rivoluzione” parliamo.
Una di quelle apparentemente più fondate e, per certi versi, rassicurante, consiste nel porre l’accento sul fatto che una massa umana che non ha idea di quanto va determinando con la sua azione è condannata allo scacco, quantomeno nel senso che gli esiti stessi della sua azione saranno sovradeterminati, e anche in questo caso con discrete sorprese, da gruppi che -bene o male- una qualche idea su dove andare ce l’hanno.
Il fatto che poi questi gruppi abbiano scoperto di essere arrivati in situazioni che nulla avevano a che vedere con le loro teorie e che abbiano pesantemente scontato quest’errore è un altro discorso.
Inoltre a partire essenzialmente dagli anni ’60 del secolo scorso si sviluppa una massa imponente di esperienze di aggregazioni comunitarie, volte allo sviluppo di culture alternative, di stili di vita non omologati e, in misura minore, di attività produttive autogestite, al punto che si può sostenere che esista una fittissima rete di movimenti libertari in senso lato che non necessariamente si dichiarano tali e che hanno limitatissimi rapporti con la tradizione anarchica.
Con ogni evidenza, le esperienze comunitarie sviluppatesi a partire dalla seconda metà del ‘900 e tutt’ora esistenti sono espressione di gruppi sociali e di esigenze radicalmente diverse e rispetto al movimento cooperativo classico e comunque rispetto ai tentativi in questo senso del movimento operaio dell’800 e della prima metà del ‘900; pure, indubbiamente, alcune costanti si danno, principalmente il voler vivere nel presente una trasformazione effettiva della propria vita.
Per parte mia, ho il massimo rispetto – e non è affermazione retorica – per questo approccio, vorrei però provare a sostenere una tesi che sospetto impopolare e cioè la difesa di un approccio essenzialmente negativo alla pratica rivoluzionaria.
Proviamo ad affrontare la questione nella maniera più astratta possibile, noi sosteniamo che sono desiderabili l’eguaglianza e la libertà ma certamente non immaginiamo una caricaturale eguaglianza intesa come somiglianza, né, tanto meno, una caricaturale libertà intesa come onnipotenza.
In entrambi i casi sono concetti che noi definiamo per sottrazione: l’eguaglianza è assenza di gerarchia e la libertà è assenza di vincoli e quindi in ultima istanza di gerarchia.
E’ questo uno degli aspetti della teoria della rivoluzione che, a rigor di logica, dovrebbero essere autoevidenti e che al contrario vedono molti affannarsi a tentare di tenere insieme eguaglianza e libertà quasi fossero in contraddizione fra di loro.
E’ ben vero che, per il senso comune, che, con ogni evidenza, influenza anche i “rivoluzionari”che pure dovrebbero a rigore essere critici nei suoi confronti, l’eguaglianza è l’appiattimento in una società organizzata come una caserma e la libertà è quella garantita dal capitalismo di mercato e fra di loro può esservi al massimo una sorta di compromesso.
Passiamo adesso a un grado di più puntuale individuazione della questione: se noi guardiamo gli effettivi movimenti di rivolta che hanno attraversato gli ultimi secoli, rileveremo che fra soggetti politici e culturali che si propongono di inquadrarli e pratiche effettive degli individui e dei gruppi sociali coinvolti vi è una distanza per certi versi impressionante al punto che questi stessi movimenti vengono orientati politicamente, di regola, solo ricorrendo a meccanismi repressivi.
In altri termini, fra rivolta delle classi subalterne e istituzione di un eventuale nuovo ordine o, quantomeno, il raggiungimento di un nuovo equilibrio di potere vi è un rapporto, ad essere cauti, problematico. Molto schematicamente si può affermare che vi una continua pressione delle classi subalterne sulla struttura produttiva e sull’assieme della società, che questa pressione è, per l’essenziale, estranea alla rappresentazione politica ed alle stesso organizzazioni formali della classe, che vi quindi un vero e proprio “altro movimento operaio” che opera fuori dal cono d’ombra dello spettacolo capitalistico e che lo fa in maniera straordinariamente, ai fini degli interessi di classe, meglio del movimento operaio istituzionale integrato nell’apparato statale e capitalistico.
Sulla base di quanto detto sin ora potremmo considerare la rivoluzione sociale, che è quasi inutile sottolinearlo è evento di natura affatto diversa dalla rivoluzione politica, come un processo lineare, attraverso il quale si accumulano le forze, le relazioni, le pratiche che arrivano a determinare un salto di paradigma dalla società fondata sullo stato e sul mercato all’autogoverno dei produttori associati.
A questa visione irenica si deve, aggiungo purtroppo, opporre alcune considerazioni sin banali:
-
quello fra classi dentro le relazioni sociali capitalistiche è una relazione conflittuale che concorre essa stessa al produrre continue innovazioni nel sistema di dominio. Questo vale per la struttura diretta della produzione, che viene continuamente rimodellata per garantire la massima efficienza possibile della forza lavoro, che nelle relazioni sociali più generali che nel capitalismo sono per grandissima parte modellate secondo le regole dello scambio e della gerarchia statuale. Non a caso, lo stesso immaginario collettivo incorpora dentro di sé i conflitti sociali passati trasformandone l’elaborazione in merce.
-
Queste stesse relazioni si misurano con l’irruzione traumatica del politico inteso come esercizio della forza, che sia statuale o privata, legale o extralegale. Di fronte a questa irruzione i movimenti sono costretti ad arretramenti, torsioni, modifiche interne; pensiamo, per fare un solo esempio, alla strage di Piazza Fontana a petto del ciclo di lotte operaie del 1969.
Da ciò deriva per un verso l’impensabilità della rivoluzione sociale se non in forma assolutamente astratta e la sua immaginabilità solo sulla base di esperienze passate, inevitabilmente fortemente distorcenti.
E’ in questo scarto che si colloca, sul piano teoretico, la critica della politica come attività alienata e separata e, su quello pratico-sensibile, l’azione volta a individuare i punti di crisi e di debolezza dell’avversario e di applicazione della forza della propria parte. Come si vede due aspetti della prassi che caratterizzano l’arte della guerra, un’arte eminentemente distruttiva.
Paradossalmente, in questa prospettiva, la sperimentazione di “territori liberati”, stili di vita alternativi, di forme di contro-economia non è da considerarsi una perdita di energie o un allontanamento in senso proprio del conflitto. La fallacia dell’ipotesi prefigurante sta appunto nel volersi prefigurazione, nel sottoporsi senza che ve ne sia alcuna necessità a una ricerca estenuante di coerenza e di purezza.
Proviamo a pensarla invece come sottrazione, come immediata affermazione vitale, che non deve giustificare nulla agli occhi di nessuno, ma solo soddisfare le esigenze dei soggetti che la praticano. Sotto questo profilo l’autogestione, da dover essere, diviene semplicemente una prassi funzionale ad uno scopo condiviso.
E’ questo, indubbiamente, un tema che va ripreso, è sufficiente per ora rilevare che le forme immediate dell’azione pratico/sensibile possono variare senza che la pluralità delle sperimentazioni metta in discussione l’unità sostanziale di un progetto generale di radicale critica al capitalismo ed allo stato ed, anzi, che la varietà delle esperienze è uno straordinario arricchimento del progetto stesso.
Si pensi, a questo proposito e per fare un esempio che anch’esso va esaminato con cura e spirito critico, a quanto sta avvenendo del Rojava e a come, stupendo positivamente noi stessi e certo chi scrive, al di fuori delle classiche zone di insediamento del movimento libertario vi sono importanti sperimentazioni sul campo.
In quest’ottica è possibile superare l’annosa e improduttiva polemica fra chi rivendica la necessità di un movimento anarchico specifico come detentore di una memoria e luogo di addensamento delle forze per lo scontro con lo stato e il padronato e chi ritiene che il moderno anarchismo si risolva in uno stile di vita, in una cultura libertaria diffusa, al limite in una sperimentazione artistica.
In effetti, il movimento specifico, chiamiamolo col suo vero nome, l’organizzazione o (perché essere bigotti?) col nome che gli anarchici usavano classicamente, il partito, o ha una funzione ben definita nello scontro fra le classi o, a rigore, non ha ragione d’essere.
Molto semplicemente è uno strumento per la disarticolazione dell’avversario: se fa questo, e se lo fa efficacemente, è assolutamente necessario ed è, come è bene che sia, radicalmente diverso dal partito-comitato elettorale democratico o dal partito di massa novecentesco di stampo socialdemocratico, menscevico o bolscevico che sia.
Ma quest’ordine di problemi necessiterebbe una riflessione a parte.
Cosimo Scarinzi