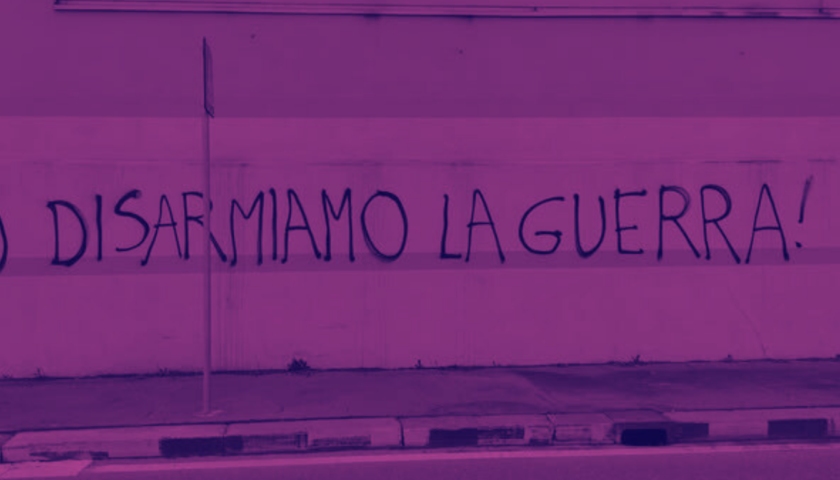È sempre più ostico in questa fase storica definire l’antimilitarismo fuori dell’etica pacifista. Vuoi per la narrazione mediatica degli orrori dei vari conflitti, vuoi per le condizioni delle popolazioni dei teatri di guerra. Miseria, emergenze sanitarie e migrazioni di massa fanno da paravento alle reali motivazioni che innescano i conflitti. Si passa quindi alla retorica dell’esportazione della democrazia, all’intervento per salvare questa o quella popolazione e a tutta la retorica giustificazionista per motivare oltre ogni ragionevole dubbio l’impiego razionale della violenza di massa. Spesso, davanti all’infamia della guerra e degli attentati, fa necessariamente capolino l’anima bella di shilleriana memoria, e l’immensa opera di compiacimento per la propria capacità di provar pietà accomoda il tutto. Si inneggia quindi al cessate il fuoco, alla pace necessaria, al dialogo, e a tutta la retorica borghese di cui si dispone, sovente sfociando nel grottesco.
Assai spesso però, a parte alcune lodevoli analisi, si dimentica a cosa serve l’impiego della macchina bellica. Partiremo quindi da un assunto o se vogliamo un’ipotesi: che non vi sia altra possibilità di descrivere compiutamente il processo di militarizzazione di un territorio al di fuori di ragioni economiche. Chi legge queste pagine da anni potrà stupirsi di questa banalità ma il problema è che la retorica dei buoni contro i cattivi, quindi il ragionamento per categorie rigide è purtroppo patrimonio di molta parte del cosiddetto movimento (sia esso definibile anticapitalista, antagonista o altro).
Si leggono analisi sui conflitti che fanno accapponare la pelle: si cerca di giustificare una azione semplicemente perché condotta da un paese inviso al nemico storico a stelle e strisce e dabbenaggini del genere. Tante, troppe se ne sono lette, ad esempio, sul conflitto siriano e ancora peggio su quello afghano. Ogni tanto porsi la storica domanda “Cui prodest?” non sarebbe un gesto antirivoluzionario ma un gesto di reale volontà per capire quale tipo di interesse stia favorendo un conflitto. Riproponiamo quindi un “fondamentale” dell’analisi anarchica sulle fasi storiche, cioè il buon vecchio approccio anticapitalista. Una lente d’ingrandimento che, per quanto possa apparire demodé, se bene usata è ancora un ottimo strumento, quantomeno per non farsi prendere per il proverbiale naso dalla narrazione totalizzante e dalla baraonda disinformativa del web.
L’operazione del capire a chi giova veramente l’esplosione di un qualsiasi conflitto che passi sotto un qualunque nome, dalla “guerra santa” alle guerre di liberazione, dai conflitti preventivi alle guerre civili, è un’operazione di grande rilevanza. Spesso ci consente di andare oltre l’ovvio apparente e scandagliare l’immensa opera di propaganda che sta dietro alla creazione della figura del nemico. Seguendo però i flussi di denaro si va ancora più lontano. Se la motivazione di alcuni conflitti sono state le risorse del sottosuolo, altre consistevano nello sgomberare rotte commerciali o controllarne il flusso – da Suez al Golfo Persico avremmo dovuto sicuramente imparare qualcosa. Alcuni conflitti sono molto più facilmente analizzabili di altri, ne convengo, ma capire chi investe su cosa fornisce sempre una buona pista per intravedere qualcosa di veritiero nelle nebbie della retorica e della propaganda.
Cosa accade invece quando le forze armate albergano in un territorio in tempo di pace? Come si spiega la presenza non gradita di organizzazioni che assumono il controllo di interi pezzi di territorio nel quale neanche gli enti locali hanno giurisdizione? Di là del loro essere la retroguardia e di presidiare punti strategici o di essere siti produttivi le spiegazioni si fanno sempre molto fumose ma, se prendiamo in mano la nostra lente d’ingrandimento, potremmo notare qualche dettaglio più nitido.
L’analisi anticapitalista, o l’analisi dei flussi economici per snudare gli interessi di grosse compagnie d’affari, ha sempre una sua funzione di contronarrazione chiarificatrice ma, riuscendo ad andare oltre, si può addirittura rintracciare la struttura profonda che lega l’apparato militare non soltanto alla società ma all’intero impalcato che sorregge il sistema socio-economico così come lo conosciamo. La macchina bellica agisce da volano economico, capitalizzando utili nelle fasi attive e ottimizzando le risorse nelle fasi passive. Prendiamo la ricerca militare, affidata su appalto a vari istituti di ricerca, pubblici o privati che siano: anche la più piccola università di provincia può avere la speranza di chiudere un contratto con la Difesa. In periodi di tagli e austerity un buon contratto milionario con chi non ha grossi problemi a pagare è sempre un buon affare per mantenere a galla un dipartimento e tutto il sistema baronale a esso collegato.
La macchina bellica però non ha solo bisogno che qualcuno gli risolva i problemi dell’innovazione a livello teorico, c’è bisogno anche che qualcuno sviluppi i prototipi e avvii la produzione delle componenti. Ogni azienda, da quella che produce trattori a quella che è dedita all’assemblaggio di minuteria elettronica, può liberamente concorrere a chiudere un buon contratto per produrre “pezzi” o sub-componenti per ogni tipo di veicolo o equipaggiamento. Finanche chi produce e commercializza oggettistica varia e accessori per toilette ha la possibilità di stare tranquillo per un po’ con una buona commessa militare che può arrivare ad assorbire buona parte della produzione.
La riconversione per il COVID fa piuttosto ridere vedendo quanto rapide sono state alcune riconversioni per produrre per le forze armate durante i conflitti degli ultimi vent’anni. Torniamo però un attimo alle installazioni militari di qualunque natura esse siano. Queste tendono a sviluppare un certo rapporto con il territorio circostante, spesso di sudditanza, il radicamento economico di certi insediamenti è però tale che intere comunità dipendono dalla loro presenza. Mettiamo il caso di San Diego: città di tre milioni di abitanti dei quali quasi un terzo è in un certo qual modo legato alle attività militari, sia direttamente in quanto in ruolo alle forze armate sia in quanto civile operante nei cantieri navali o nelle varie ditte che si occupano di manutenzione, pulizia e altro. Oltre poi a questo imponente numero di persone operanti direttamente nella base o nel porto, c’è un indotto produttivo, dall’industria all’agricoltura che assorbe altra forza lavoro che vede stime oscillanti tra le due e le trecentomila unità. Stiamo parlando di un movimento di mezzi, persone e merci tale che anche la profonda crisi del 2008 non è riuscita ad incidere sull’area di San Diego tanto quanto ha colpito, ad esempio, New York o altre zone: l’effetto inerziale della presenza dell’installazione militare ha quasi assorbito per intero la crisi locale.
Ora, dopo questa piccola esposizione degli interessi radicati in un territorio marcato dalla presenza militare, possiamo cominciare a tirare alcune conclusioni circa il connubio indistricabile di economia e militarizzazione. È chiaro che se si vive in un territorio nel quale l’installazione militare sembra avere risorse economiche infinite, consuma e paga mentre altre situazioni paiono languire, il pensiero non si attarda neanche più a ponderare questioni etiche ma sale quasi spontaneo un bel: evviva l’esercito! Pensiamo veramente che chi, di riffa o di raffa, riempie le pance di una quota parte della popolazione civile possa poi essere messo in cattiva luce solo perché sono degli assassini con licenza ministeriale e benedetti da un dio a caso? Crediamo veramente che in una società sempre più precaria, nella quale la scelta della carriera militare è rimasta una delle poche se non l’unica speranza di un posto fisso statale, ci sia molta gente disposta a farsi arrestare per protestare contro la guerra perché è brutta e lascia orfani centinaia di minori?
Fintanto che l’opera di militarizzazione e gli sforzi bellici continueranno a essere l’ariete che sfonda le resistenze di qualche paese o territorio, nel quale le trattative commerciali e quelle diplomatiche hanno fallito o continueranno a fornire domanda a un’industria in affanno o essere i migliori acquirenti locali che garantiscono la fuoriuscita da una crisi, crediamo in tutta coscienza che bastino delle manifestazioni per decretarne la scomparsa? Se smussassimo le asperità di talune visioni antimilitariste che probabilmente hanno ancora ruggine contro l’operato di Garibaldi, riusciremmo a ricostruire la rete fitta e complessa di interessi che lega la società civile agli eserciti e questi alle strategie finanziarie e commerciali che innervano il pianeta e, forse, si potrebbe cominciare a capire l’entità del fenomeno.
Si capirebbe anche l’assoluta ingenuità di certo pacifismo di maniera incapace di vedere lo sforzo bellico per quello che è: uno strumento, forse il più efficiente e duttile, del modo di riproduzione capitalista. Il quale non si limita a radere al suolo paesi e città ma porta avanti un’opera assai più infida e perniciosa, quella dello sradicamento di istanze socio-culturali per reimpiantarne altre. La narrazione eroica, la ricerca del nemico, l’incursione nella società, la garanzia produttiva e tutto il sistema di penetrazione all’interno del tessuto socio-territoriale sono quegli aspetti spesso rimossi da certa retorica antimilitarista melensa se non addirittura bolsa. Restano le propaggini tossiche dell’apparato che riesce ad avviluppare interi pezzi di territori spesso più staccando assegni che sparando missili.
J. R.