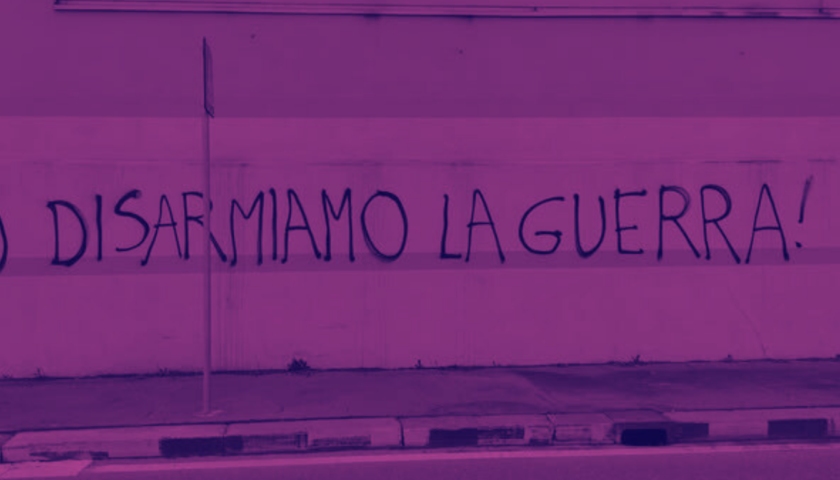Prologo
Assumo come ipotesi il fatto che l’attuale fase storica, nella sua complessità, sia spesso fraintesa, non sufficientemente indagata e spesso interpretata parzialmente e tendenziosamente. Questa ipotesi, a mio modesto giudizio, calza purtroppo a pennello a molta parte del pantheon politico, tanto dal lato istituzionale o istituzionalizzato, quanto da quello che per comodità continueremo a definire movimentista. Credo che la crisi di comprensione del cambiamento in atto, sia divenuta incontrovertibilmente evidente con Genova 2001, c’è stato un momento in cui, peccando di presunzione giovanile, ebbi a dire che Genova fu l’inizio della spirale discendente del movimento, in realtà ho dovuto ricredermi.[1] Quel momento ha rappresentato l’evidenza di una crisi già in atto, che fino a quei giorni covava sottotraccia, un lento processo di dismissione progressiva dell’agire il conflitto, portandolo sempre più dai territori ai tavoli di concertazione.
In poco più di due lustri lustri dal ’78 all’’89 è stata operata una destrutturazione costante del linguaggio politico, seguito a ruota da quella del significato dei concetti espressi da quello stesso linguaggio. Ad un tratto significati e pratiche hanno cambiato radicalmente senso. Tutto ha cominciato a divenire “evento”, il conflitto è divenuto un evento estetico, da narrare con enfasi, i sit-in sono diventati flash-mob, lo scontro di piazza un evento epico, la morte di un compagno un martirio, ecc. In pratica prima abbiamo lasciato marcire i concetti teorici che hanno supportato l’azione politica per un paio di secoli, finendo poi per abbandonare anche i significanti, preferendo coniare neologismi intriganti che tenessero il passo con la penetrazione del linguaggio neoliberista in ogni dove, diventando “fluidi” ed atomizzati per meglio incarnare la società, ma pretendendo di interpretarla come se ne fossimo al di fuori.
Andiamo però oltre. Le lotte sono diventate “campagne” da riarticolare di anno in anno cambiando obiettivo e ridefinendo le strategie: così e di stagione in stagione quello che contava era “stare sul pezzo” ed egemonizzare quella specifica lotta facendola poi risaltare come la madre di tutte le lotte. Di anno in anno, di campagna in campagna e di corteo nazionale in corteo nazionale, il moto di deriva si faceva sempre più rapido, finché l’unico intento reale non è stato quello di egemonizzare un conflitto, ora tutto interno al movimento, salvo poi fare contorsioni filologiche per incastrare rivendicazioni varie ed eventuali, in piattaforme di manifestazioni tra le più improbabili; per fare numero tutto fa brodo tanto all’indomani del corteo nemici come prima.
Lo scollamento con la realtà e la difficoltà di analizzare la fase si sono tradotte in una quasi totale incomprensione dell’agire politico movimentista, proprio da parte di quei soggetti che avrebbero dovuto essere l’effettivo riferimento di classe (si sarebbe detto un tempo). Quindi linguaggi nuovi e scopi cangianti hanno trasformato l’avanguardia movimentista in una carovana al traino degli eventi, con annessi il rifiuto per ogni tipo di organizzazione ed una sorta di fobia per le utopie. L’hic et nunc come strategia, e la derubricazione dell’analisi della fase ad un mero “far poesia”, anelano ad una concretezza dell’azione che riproduce sé stessa. Un viaggio di sola andata ad abbracciare la postmodernità, per cui esasperando tutto ed in un impeto di zelo s’è buttato via il bimbo, l’acqua sporca e tutta la tinozza.
Cosa che s’è guardato bene dal fare il pensiero capitalista, o neoliberismo se preferite, che sbarazzatosi di ogni tipo di convincimento teorico di lungo respiro sostenuto da uno straccio di utopia ha potuto urlare che l’ideologia è morta, che il fardello del ’900 è stato gettato alle spalle, che finalmente guardiamo in faccia il futuro e possiamo realizzare ognuno il mondo che vuole.
Parole troppo spesso sentite anche in tante assemblee; superare il ’900 magari reinventandosi la rivoluzione. In questo forse Genova è stata la chiusura di una stagione e l’apertura di una fase confusa e convulsa. L’ultimo grande momento di immaginario collettivo ma che già aveva perso aderenza con la realtà. Peccato che il mantra della fine delle ideologie sia un’ideologia in sé, che si nasconda nell’estrema evidenza del suo esserci. La forma mercato ha talmente infiltrato tutto il sensibile che spesso non si fa neanche caso al fatto di parlare la sua stessa lingua. Si scavano nicchie nel mercato nella convinzione di esserne affrancati, un misto tra una buca per struzzi ed un loculo per le rivoluzioni. L’importante è chiamare questi loculi in maniera consona, aggettivandoli come clandestini, fuori mercato, anticapitalisti, etici, equi o solidali. Il nome è suggestione e la suggestione è tutto, ti fa sentire parte di qualcosa, partecipe o addirittura sostenitore attivo di un processo “differente”.
Differente da cosa? Questo è uno dei punti in cui si inciampa più spesso, se la rivendicazione dalla pretesa del cambiamento di rotta attraverso un’azione di forza collettiva o un tentativo di costruzione di alternative praticabili, passa ad una richiesta rivolta alla governance, qualcosa comincia a non funzionare.
Se la rivendicazione non è più mirata all’ottenimento di un’esistenza libera da legacci ma alla possibilità di sentirsi liberi di comperare quello di cui prima non sentivamo la necessità, se il conflitto è per recuperare un vantaggio perso con la chiusura della stagione delle vacche grasse, c’è un problema. Se da un genuino rifiuto dell’esistente come narrazione del potere dominante si passa a voler “cambiare le cose dall’interno” vuol dire che il paradigma è stato capovolto e l’alternativa diventa il famoso “tutti a casa”, con l’implicito “ora ci pensiamo noi”. Una parola d’ordine trasversale che va da un capo all’altro del parlamento ma che ora comincia a rimbombare nel vuoto del movimento. Un vuoto anche fisico, che si misura negli spazi di agibilità lasciati al primo che passa, dall’arruffa popoli in cerca di qualche voto, ad improvvisate teorie anti qualcosa che riprendono slogan che richiamano a battaglie storiche del movimento.
Anche in questo però si ravvede la stanchezza della fase, lì dove ci si dovrebbe prendere la briga di capire il perché del proliferare di “rivoluzioni” e movimenti dal respiro corto, ci si abbandona alla critica feroce, spesso foriera di una genuina invidia – perché loro portano gente in piazza e noi no? – e l’insana invidia per un evento riuscito ad altri spalanca le porte della frustrazione. Manca però quella genuina curiosità del voler capire, la “pietà del domandare” si sarebbe detto un tempo. Domandarsi il perché dei fenomeni invece di liquidare il tutto elargendo patenti di imbecillità agli astanti.
Quelle persone, quelle categorie sociali, quei vissuti sono i pezzi rotti rimasti dopo il collasso dell’agire politico nel reale e lo sviluppo dell’agire virtuale. Sono i tasselli del puzzle della responsabilità collettiva di aver optato per la visibilità delle lotte al posto dell’incisività reale nei territori. Quando si è scelto di creare opinione invece che consapevolezza, di polemizzare invece di criticare, si è dovuto giocoforza adattarsi alle nuove regole: da qui il proliferare di nuovi linguaggi per esprimere un disaggio vecchio quanto l’avidità umana.
Morale della favola non solo non ci capisce più nessuno ma non ci capiamo neanche tra noi. Divide et impera, noi a scannarci strologando sui punti e virgola e sulle innumerevoli sfumature dell’oblio che ci stritola, mentre la governance, globale o locale che sia, invece parla la stessa lingua da Bombai a Canicattì, da New York a Mexicali. In ogni contesto locale il capitale si riproduce con le stesse identiche logiche adottando tattiche e strategie differenti in quanto ogni territorio offre risorse differenti: quindi si è ben pensato di creare solidarietà fra i conflitti cercando di trovare un comune denominatore ai fenomeni per unire le lotte. Unico problema riscontrato è che spesso questi tentativi di unione somigliavano più a delle joinventure che a strategie di superamento delle differenze. Quello che metteva il capitale maggiore aveva più diritti di altri o chi si trovava ad avere in casa la madre (stagionale) di tutte le battaglie dettava il passo. Un turbinio di assemblee ufficiali e incontri carbonari a latere, sgambetti e colpi bassi da far impallidire finanche i lupi di Wall Street.
Frustrazione e dintorni
Se dovessimo, e dobbiamo, a questo punto delineare in sintesi il movimento o i movimenti di opposizione, in Europa in generale ed in Italia in particolare, si dovrebbe quindi affermare che si sono contraddistinti per l’eterogeneità delle tematiche trattate, prontamente controbilanciata da una debolezza latente che si è tradotta in una discontinuità strutturata; le campagne annualmente diverse, l’inseguire l’evento o farsi dettare il passo dalle agende di qualcun altro. Il tatticismo in luogo delle strategie meditate, un’idiosincrasia progettuale che trascina con sé forti problemi organizzativi; è difficile tenere coeso un gruppo se di anno in anno si fa tutto e il contrario di tutto.
Il capitalismo impera, in quanto la sua fisiologica schizofrenia appare come una mite eccentricità rispetto ad analisi contrastanti, spesso incomprensibili, fatte da molta parte dei suoi detrattori. Il neoliberismo si impone come unica e sola realtà possibile non in quanto tale ma per il semplice e banalissimo motivo che non vi si oppone nulla di “altro”. Altro non in senso antitetico o alternativo ma di radicalmente incompatibile, non un semplice opposto o contrario ma qualcosa di assolutamente contrastante e conflittuale. All’individualismo spinto ed all’atomizzazione sociale si dovrebbe contrapporre la necessità strutturale dell’agire comunitario ma non è così semplice: bisogna sradicare il concetto di “Io” e quello di “Mio”, il mio problema è “Il” problema in quanto sono Io che lo patisco.
A questa posizione si è risposto spesso e volentieri con tentativi inconcludenti di collettivizzare una vertenza sperando che guardare tutti verso la stessa direzione potesse indurre un cambiamento dall’io al noi ma, evidentemente, questo non basta. Evidentemente manca qualcosa. Una proposta praticabile antisistemica, che riesca a mettere in crisi i fondamenti strutturali di quella che ci viene imposta come unica realtà possibile. Un realtà nella quale sei non in funzione del fatto che pensi – anzi quello meno lo fai e meglio è – ma esisti solo se sei un utente, un utilizzatore, un consumatore quindi pesi per il debito che sei o per il tuo potere d’acquisto.
Se l’unica proposta alternativa che il o i movimenti sono in grado di elaborare è liberarsi dalla precarietà stabilendo pratiche di autoreddito senza però scardinare il sistema che riassorbe quel reddito nel consumo tradizionale, si continuerà ad essere ingranaggi di un sistema che ha un modo alternativo di portare linfa al processo di riproduzione capitalista. Anzi ancor peggio si agisce da ammortizzatori, garantendo la circolazione economica anche lì dove apparentemente ci dovrebbe essere il reddito zero, flussi flebili ma costanti che poi tornano sempre in quello principale. Non si incappa spesso in proposte di progressivo abbassamento dell’esigenza di reddito attraverso pratiche di mutualismo conflittuale. Al più si assiste alla banalità del baratto od alla banalizzazione del concetto di “time bank” in una pratica per personaggi frustrati che hanno bisogno di lavarsi la coscienza o lenire la loro frustrazione “aiutando il prossimo”.
Davanti all’incapacità di strutturare un sistema per vibrare una stoccata in un punto vitale del processo di riproduzione del capitale ci si arrabatta nel vissuto reale, si intraprendono crociate, si sovraccarica di senso anche l’azione più insignificante e nel momento in cui i riflettori si spostano su qualcos’altro si ripiomba nell’oblio. Si imbastiscono battaglie territoriali dimenticandosi spesso del territorio, si tenta di cavalcare anche l’onda più piatta, si riempiono le piazze più per far capire di esistere che per ottenere qualcosa ma, alla fine, resta solo una grande frustrazione, quella di non essere riusciti a cambiare neanche le nostre esistenze personali.
Voto ergo sum
Il punto di rottura oramai raggiunto e superato quasi vent’anni fa ha posto una serie di interrogativi e sfide, in verità quasi mai raccolti o addirittura quasi mani neanche ponderati come tali. Rompere col sistema più che rompere il sistema. In questa fase storica il sistema è estremamente agile e cangiante difficile da rompere non essendo un regime monolitico. La capacità di sussunzione da parte del mercato è tale che nel momento in cui stiamo ancora a chiederci il perché di un qualcosa ed a baloccarci con idee di contropotere, il linguaggio del mercato ci ha già superati rubacchiando slogan e parole d’ordine e risparandoceli addosso come spam pubblicitario. Il marketing prende tutto quello che gli serve e lo trasforma in consenso ed opinione interessata, dalle esperienze della produzione biologica e biodinamica abbiamo ottenuto di dare un assist alla grande distribuzione che ora fa linee di produzione di “healthy food” molto più economiche di quanto si trova nei mercatini dei GAS o di genuino clandestino e chi ha gli spiccioli contati in tasca ma vorrebbe dare ai suoi cari cibo decente tenderà a credere allo spot della famigliola felice e dei contadini allegri.
Bisogna cambiare le regole quindi! Sembra essere il mantra imperante. Come si cambiano le regole? Behm se si gioca sullo stesso terreno le regole non le facciamo noi, quindi si cerca di cambiare qualcosa sulla quale non abbiamo controllo, quindi l’idea di andare a premere qualche bottone a caso nella cabina di regia. Qual è però a regia? Dov’è la cabina? Sicuramente non è quella elettorale e la sala comandi non è il parlamento; allora forse sta nel governo del territorio, da qui forse la smania di farsi eleggere sindaco in piccoli comuni nei quali lavorando qualche anno forse ci si arriva. Peccato che i giochi si facciano altrove e che il parlamento ratifichi i dispositivi strutturali e poi si accapigli su idiozie, tipo crocifissi nelle scuole ,quando oramai non ci sono neanche più i muri per attaccarceli. I comuni più sono piccoli e meno decidono, soprattutto se fanno parte di aree metropolitane, più però sono piccoli e più si pensa sia fattibile prenderli. Ma anche se ci si riuscisse, tra fiscal compact, patto di stabilità pareggio di bilancio e altre allegre trovate, al massimo si ha la libertà di ridisegnare la toponomastica.
Morale della favola, perse le piazze, persi i quartieri, perso il contatto con la realtà si corre nelle competizioni elettorali per dare un senso alla propria frustrazione e per poter poi incolpare il resto del mondo di non averla spuntata. Questo nella migliore delle ipotesi, nella peggiore si prende un posto, un seggio, un posticino da consigliere o un parlamentare, per farci cosa? Per contare meno dell’istituzione nella quale si è stati eletti?
J.R.
NOTE
- Jammy, “Generazione Genova”, in Umanità Nova https://www.umanitanova.org/?p=2315